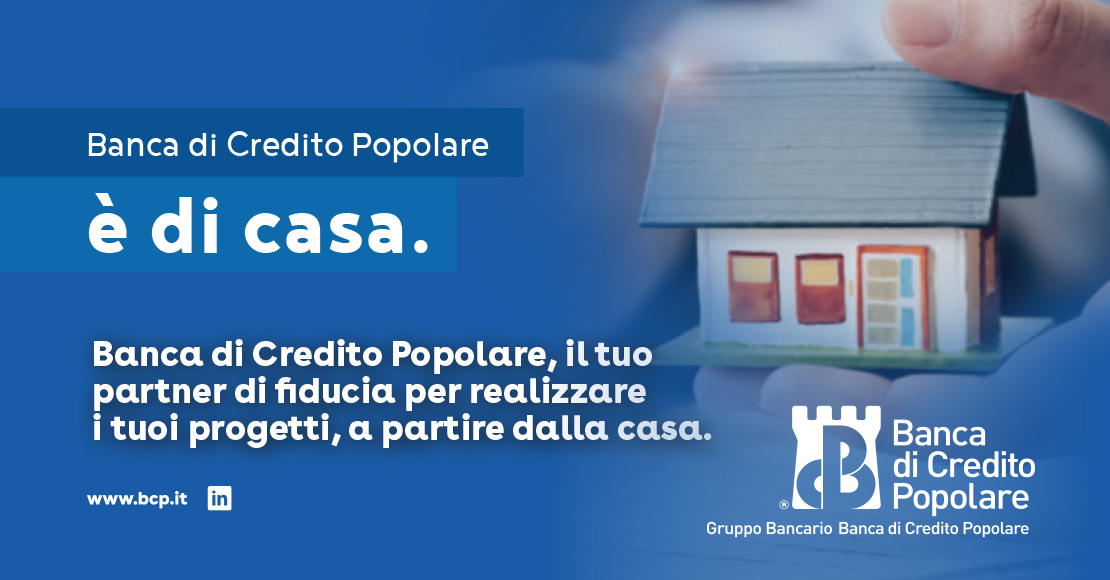Brucia mezzo Stivale (fino al ginocchio): è un problema di algebra
Tutti sappiamo tutto. Tutti abbiamo visto lo Stivale bruciare fino al ginocchio, a partire dalla punta. E pure i conti non tornano. Ci sarà un errore di calcolo?
Aristotele, filosofo greco del IV sec. a.C., ne La Costituzione degli Ateniesi, riferiva che “se qualcuno estirpava o tagliava un olivo sacro, lo giudicava il Consiglio dell’Areopago, e se lo riconosceva colpevole, lo condannavano a morte”. D’accordo, siamo all’origine della democrazia, quindi queste pratiche incivili e tribali erano ammesse. Oggi, in una Repubblica democratica ciò sarebbe intollerabile: condannare a morte un essere umano perché taglia un olivo?! Chissà quale pena avrebbero decretato per chi avesse bruciato un intero uliveto, delle montagne e distrutto diverse colture. L’avrebbero giustiziato senza alcun processo?! Ma quella era una democrazia di principianti: di altra sostanza la nostra Repubblica democratica. E infatti, nei principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, l’Art. 9 parla proprio di “tutela del paesaggio”. Poi… poi basta! Nessun accenno agli olivi, a qualche varietà di alberi, alle colline, alle montagne, alle foreste… nessun accenno al nostro patrimonio colturale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”, ma nessuna coltura è compresa in questa difesa e promozione. Però la Costituzione “tutela il paesaggio”. In che modo? In un modo democratico. Qui non solo si tagliano e si estirpano gli olivi sacri e secolari, ma si bruciano interi oliveti, montagne e parchi naturali che dovrebbero essere protetti. Ma questo non è una civile questione di democrazia, siamo di fronte ad un evidente problema di algebra: gli italiani, a differenza degli Ateniesi, non sanno analizzare relazioni e funzioni un po’ più complesse, non hanno ancora appreso la Teoria degli insiemi. Sanno appena risolvere problemi aritmetici, del tipo “il contadino va al mercato…”. Sanno fare calcoli semplici e immediati: se mi danno 50euro in cambio di un “favore”, io faccio la spesa oggi. Le conseguenze remote di tali azioni non sono considerate, perché si tratterebbe di un’analisi complessa di algebra e noi siamo incapaci di gestire queste operazioni. Una relazione verosimile potrebbe essere che un domani mio figlio sarà costretto a emigrare, o magari lo condannerei ad accettare il mio stesso destino di “favori”: forse, ripensando alle conseguenze prevedibili, avrei fatto meglio a digiunare in cambio di un futuro migliore per mio figlio. Purtroppo, noi a scuola abbiamo sempre criticato lo studio di una certa matematica, sostenendo che per vivere basta saper risolvere calcoli elementari: più (+) o meno (-), divido e moltiplico e i conti tornano. Ma se poi allargo la mia sfera d’azione, i miei orizzonti e mi accorgo che faccio parte di un insieme, procedimento e calcolo sono del tutto scorretti. Se avessimo studiato a scuola un po’ più di matematica, ci fossimo applicati nel risolvere problemi più complessi di algebra, sapremmo ora valutare le relazioni, le conseguenze, le ricadute sugli “insiemi” di ogni nostra azione. Semplifico: se io danneggio (incendio) l’ambiente in cui vive l’uomo e di cui si nutre, di conseguenza arreco un danno all’uomo. Giusto?! Ora, per il semplice fatto di appartenere a un gruppo: se io danneggio l’uomo e io faccio parte di tale gruppo in quanto uomo, allora sto arrecando un danno a me stesso. È una semplice teoria degli insiemi: a ∈ A {\displaystyle a\in A} a (uomo) b (animale) c (albero) ∈ (appartengono) A (insieme-ambiente, il “paesaggio” tutelato dalla Costituzione), allora tutto quello che riguarda A (paesaggio) coinvolgerà a b c, e quindi se a è in relazione con b e b con c, per la proprietà transitiva a sarà in relazione con c, e le conseguenze ricadranno su tutti e tre gli elementi. E lo stesso vale per le funzioni: qual è la funzione di un uliveto, di una montagna? Qualsiasi speculazione all’infuori della sua funzione produrrà miseria prima o poi, che peserà sull’insieme.
Bertrand Russell, ne Il Cinismo dei giovani, scriveva: “un finanziere può operare liberamente senza sapere un bel nulla dei molteplici effetti delle sue attività, salvo, naturalmente, l’effetto controllabile sul suo conto in banca. Come sarebbe bello un mondo in cui nessuno potesse diventare agente di cambio senza avere superato un esame di economia e di poesia greca, e in cui i politicanti fossero costretti ad avere una profonda e aggiornata conoscenza della storia e della letteratura moderna! Immaginate un magnate posto davanti a questa domanda: «Se vuoi creare un monopolio del grano, quali ne sarebbero le conseguenze sulla poesia tedesca?» […] Coloro che controllano tali organizzazioni sono uomini ignoranti, incapaci di prevedere la centesima parte delle conseguenze delle loro azioni”.
Ecco, siamo di fronte a una semplice, una complessa analisi di relazioni e funzioni algebriche, in tempi in cui, la maggior parte di noi, soprattutto chi detiene poteri e monopoli, è incapace “di prevedere la centesima parte delle conseguenze delle [proprie] azioni”, di determinare relazioni tra ‘due o n’ insiemi e funzioni di due o più variabili: è un evidente problema di algebra, per un’umanità ferma all’aritmetica, alle tabelline.
Gerardo Magliacano



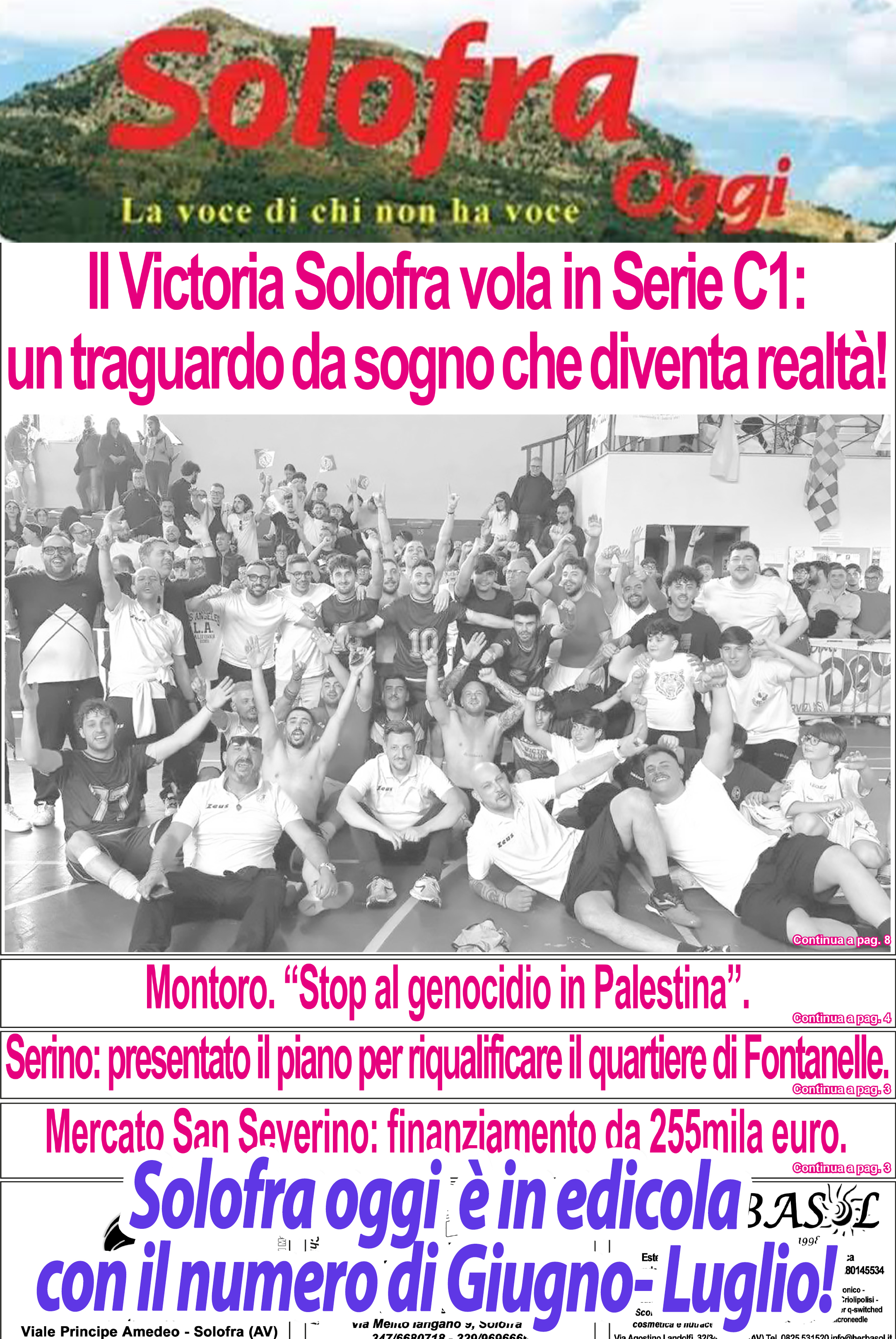
.jpg)

.jpg)

.png)