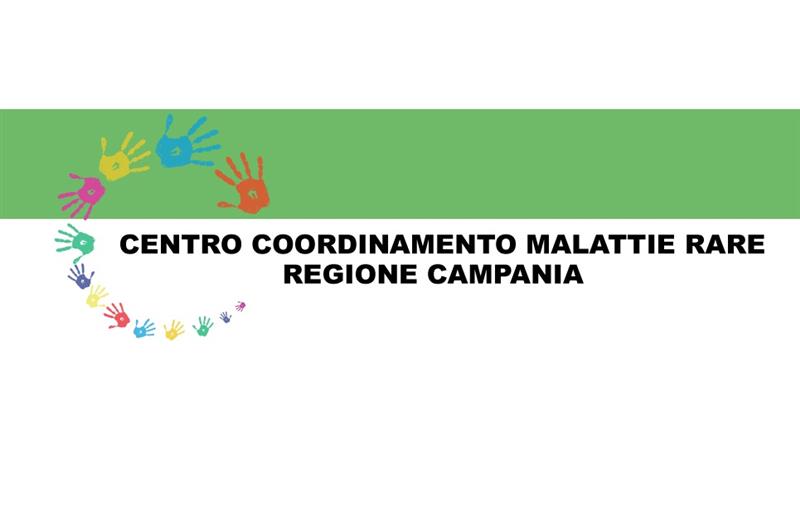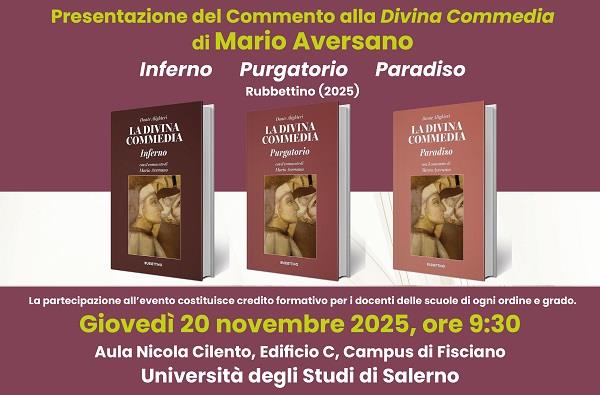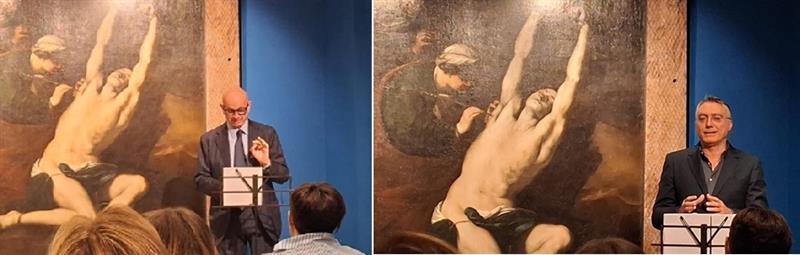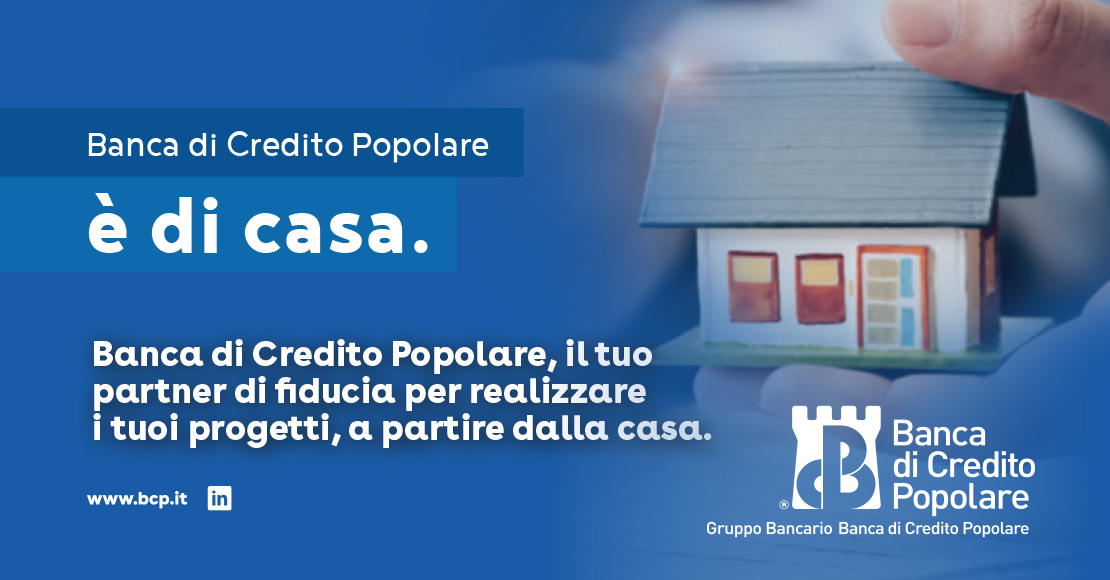DOMENICO DEFELICE alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata
col suo recente libro A RICCARDO (e agli altri che verranno)
L’agile volumetto, edito in bella veste tipografia da Il Convivio di Castiglione di Sicilia, venerdì 24 aprile 2015 è stato presentato presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata.
Organizzatore e a relatore dell’evento è stato il prof. Carmine Chiodo, il quale ha messo in evidenza i vari pregi dell’opera, ideata da Defelice, è vero, per omaggiare il nipotino Riccardo e l’altro appena arrivato Valerio, ma, principalmente, per difendere la famiglia.
Sono intervenuti anche lo scrittore Tito Cauchi e la laureanda Claudia Trimarchi, i quali hanno suggerito particolarità importanti non solo riferiti al libro in specie, ma al complesso dell’opera defeliciana, da sempre aperta al civile e al sociale.
Carmine Chiodo ha affermato che molti scritti di Defelice affondano nell’autobiografismo, particolare confermato dall’autore nel suo intervento, rispondendo alle domande di un gruppo di studentesse e leggendo pure alcune sue poesie, anche da precedenti sue opere, come “A mio padre”, tratta dal volume Canti d’amore dell’uomo feroce (1977), e “La luce e il serpe”, dal volume La morte e il Sud (1971).
Una piacevole e interessante iniziativa questa voluta dal Prof. Carmine Chiodo, nei confronti di un autore che, a suo dire, meriterebbe di essere ancor più letto e valorizzato, se non altro per la carica umana e sociale che caratterizza ogni suo scritto.
Ecco quanto scrive dell’opera la scrittrice Liliana Poro Andriuoli, di Napoli:
IL miracolo del nascere della vita sul mondo, che rinnova ogni volta in noi l’antico stupore, è stato scelto da Domenico Defelice come tema portante del suo recente libro di versi, quasi interamente dedicato all’amatissimo Riccardo, il suo primo nipotino, figlio della figlia Gabriella. A Riccardo (e agli altri che verranno) è infatti il semplice, ma eloquente titolo del libro.
Il tema non è certamente nuovo nella nostra letteratura, ma Defelice lo tratta con quella freschezza e con quello slancio che lo fanno apparire ancora una primizia, sia allorché, rivolgendo lo sguardo al passato, pensa al nipotino come a colui che discende da “un albero vetusto / che affonda le radici nei millenni” (“Sei il primo fiore / impastato con le mie cellule, / tasselli d’un albero vetusto / che affonda le radici nei millenni”, Il primo fiore) sia allorché, proiettato nel futuro, vede il bimbo, ormai adulto, vivere la propria vita in un mondo migliore di quello in cui è vissuto il nonno (“Penso
come sarà il mondo / visto dai tuoi occhi, / quello che non sarà più mio”, Forse…) ed auspica per lui una Terra ideale, in cui tutti possano vivere una vita degna di essere vissuta (“Ci saranno strade affollate solo / di passanti sorridenti e felici / e piazze brulicanti di bambini”, ivi).
Preso dall’emozione, il neo-nonno confida al nuovo nato di aver piantato per lui, il giorno della sua nascita, un albero in giardino, quale segno di augurio affinché “fra cent’anni”, ormai “vecchio”, possa godere, “felice”, ancora della sua fresca “ombra” (“Ventisei ottobre duemilanove! / … // Bello e biondo, come tua madre. // Nuova vita, nuova stella, / luce nuova per noi tutti s’è accesa. / … // Nel tuo nome ho già piantato un leccio. / Insieme crescerete. Fra cent’anni / vecchio t’immagino e felice / godere alla sua ombra”, Ho piantato un leccio).
Ma il pensiero di Defelice spazia anche al di là di queste manifestazioni di pura e spontanea gioia che egli ora, come un qualunque nonno, prova nel vedere prolungarsi una parte di sé nel nipotino (“È sbocciato un fiore / nel ventre di mia figlia. … // Sotto la scorza ruvida / di vulcano addormentato / mi bolle il sangue come lava”, L’annuncio). Egli infatti esprime anche alcune considerazioni generali, che investono la sfera morale e civile dell’uomo: “Dicono che ancora non sei niente. / I laici lo dicono e la legge: / per giorni ancora, / fino a tre mesi” (Dicono…). Ora per Nonno Domenico tutto ciò non è vero, perché per lui il bimbo è già un essere vivente dal momento in cui gli è stata comunicata la notizia del suo concepimento, seppure manchino ancora tanti mesi alla sua nascita… I genitori gli hanno anche già dato un nome (“Han deciso: ti chiamerai Riccardo. / Il nome recherai di prodi e forti”, Ti chiamerai Riccardo) ed egli pensa al futuro di questo piccolo embrione. Lo vede, ormai adulto, arricchire la folta “schiera” di uomini illustri che si sono chiamati “Riccardo” come lui: dal “leggendario re inglese” al “Vescovo di Andria, / anch’egli inglese”; dal “gran Santo di Wych”, un vero e proprio “astro di carità”, al medico “Pampuri”, che dedicò alla “cura di anime e di corpi” la sua vita. Tutti uomini buoni e generosi, ricordati essenzialmente per le loro doti morali e tutti con lo stesso suo nome: Riccardo. Fra questi suoi illustri omonimi predecessori e tra tanti “altri ancora” potrà scegliere, domani, il suo modello di vita: “Sarai tu stesso a sceglierti il campione. // Ricco ed ardito: / come lo sono i cuori degli eroi” (Ivi).
Molta è la tenerezza che prova Nonno Domenico per il nuovo nato e profonda è la gioia che invade il suo animo, allorché scopre in lui i gesti che già furono dei figli e che saranno di tutti gli altri figli dei figli che verranno in seguito. Così si commuove quando il bimbo sorride o piange; ed è rapito dalla visione della madre mentre se lo stringe al seno. Ma ancor più lo commuovono le moine che il bimbo fa per attirare l’attenzione degli adulti e soprattutto la sua meraviglia di fronte al rivelarsi delle apparenze del mondo esterno: “All’improvviso un ritmo t’incanta: / l’arte amerai che la parola avanza, / che sembra muta e invece al cuore / più profondamente parla?” (Sorriso legato alle galassie).
In tal modo, giorno dopo giorno, tra la commossa e costante ammirazione del nonno per i suoi continui progressi, ha inizio l’avventura del piccolo Riccardo sul mondo; un’avventura che lo porta a fare continuamente nuove esperienze e nuove scoperte che accrescono il suo sapere: “T’incanta lo schermo del computer. / Mi scruti digitare. / Seduto sulle mie ginocchia / cerchi imitarmi sulla tastiera / battendo le manine alla rinfusa” (In voi spontaneo, naturale); “Sei partito per una vacanza in Sardegna. / … // Sei salito sopra una nave / a neppure un anno. / Io ne avevo venti!” (L’amico Salgari, sopra tutti amatissimo). È questa l’avventura che lo porta a compiere sorretto dai parenti i primi passi per poi, domani, prendere da solo la sua strada nel mondo: “Un anno, il primo! / Se non cammini ancora spedito / è per la troppa fretta di andare…” (La poesia del suo scorrere lento); e, poco dopo, soggiunge: “Da qualche mese cammini. / Libero finalmente / d’esplorare ogni angolo di casa. / Verrà la strada, il mondo, / col mistero della vita, fitto fitto / che preziosa la rende, affascinante” (Inseguire verità e bellezza).
Così i giorni si susseguono assidui e veloci e, col loro trascorrere, Riccardo cresce e s’impossessa del dono della parola, che per il nonno ha echi dolcissimi: “A chiamarmi nonno / è stato per telefono, dal mare / di Puglia arroventato” (La prima volta), ricorda ancora con emozione. E, dopo le prime parole, ecco il momento in cui il bimbo pronuncia le prime frasi. Particolarmente gradite risultano al nonno quelle che rivelano la fiducia che Riccardo ripone negli adulti che lo circondano, e in particolare in lui: “Nonno, dici alla nuvola di andarsene? / Voglio il sole.” (Forse, in qualcuna, scorgerai il mio volto). È infatti convinto, il piccolo Riccardo, che il nonno sia onnipotente e che, quindi, possa anche “comandare le nuvole” a suo piacimento: possa pertanto far allontanare “quelle nere / che coprono il cielo di gramaglie”, lasciando solo i bianchi cirri a brucare a loro piacimento nell’“azzurra prateria” del cielo.
Ed ecco poi, col passare del tempo, anche il momento in cui per Riccardo giungono inevitabili i primi dispiaceri e le prime angustie: “Neppure due anni / e già ti assilla la Scuola Materna / … / Un assaggio. Uno dei primi. / Il meno lacerante / di quelli che la vita ci riserba” (Un assaggio). Ed è questo il momento in cui giungono anche i primi divieti e le prime regole da rispettare: il momento in cui Riccardo deve cominciare a comprendere, anche se è ancora un bambino, che non tutto ciò che ci circonda ci appartiene e che anche gli altri esistono, con uguali diritti e doveri; sicché la nostra libertà finisce dove inizia quella altrui.
Avviene allora che, di fronte al bimbo che “con forza, / quasi con cipiglio” afferma “E’ mio!”, il nonno senta il dovere di educarlo e si assuma il compito di fargli “capire che mio / sta bene insieme a tuo / nostro vostro loro” e che “Nessuna cosa è bella nella vita, / la vita stessa se non [è] condivisa” (La vita stessa se non condivisa).Nascono così in tanta felice armonia, anche i primi contrasti tra il nipote (che vuole vedere realizzato qualunque suo desiderio, ma che ancora non distingue “il giusto dall’ingiusto”, / il bene dal male”) e il nonno, che è dibattuto fra il desiderio di accontentare il nipote e il dovere di insegnargli a distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è, e che per questo suo dissidio prova dolore: “Il cuore lacerato ho dalla pena / allorché non ti parlo, deciso / a punire i tuoi capricci” (Anche a costo di vederti piangere).
Si tratta comunque di contrasti di breve durata, dato che ben presto l’armonia ritorna fra loro e il nonno può nuovamente raccontare al nipote Le fiabe, tra divano e poltrona e vivere con lui “istanti felici”: “Cinque anni, Riccardo! / Torno a guardarti / giocare accalorato. / … / Che gioia la tua festa! / Non sarà così sempre. / Ma ti siano stimolo e fortezza / questi istanti felici” (Ti siano stimolo e fortezza).
Ed infatti anche per Riccardo giunge purtroppo l’esperienza del dolore; un piccolo dolore, causato dalla morte di Meghi, un semplice cane, la cui memoria però “è rimasta nel cuore” del bimbo per lungo tempo: “Ogni tanto mi parli di Meghi / a mesi dalla morte. / T’è rimasta nel cuore. / Gli occhi ti si appannano”. Rapido allora in questi momenti interviene il nonno, che cerca di distrarlo e di fargli dimenticare la prima esperienza dolorosa della sua vita… (Meghi).
Riccardo non è destinato comunque a rimanere a lungo l’unico nipote di Nonno Domenico dato che Emanuela, la moglie del figlio Stefano, è già in attesa di Valerio, che nascerà infatti poco dopo la pubblicazione di questo libro, la cui seconda parte gli è dedicata. Si tratta di una parte composta soltanto da cinque poesie, e quindi numericamente più esigua rispetto alla prima, ma ricca di una calda umanità, che tutta la pervade. Anche a Valerio il nonno riserva parole piene di grande affetto: “Appena percepito, / appena un’unghia / e già ansie procuri / a noi che ti aspettiamo, / alla tua mamma” (Perché tu venga); “Sei atteso a primavera, / nel sorriso di aprile. // Quale sarà il tuo ruolo / nel teatro del mondo / non è dato sapere; / esso, però, sta scritto già dal Fiat / nei disegni divini” (Il tuo ruolo nel teatro del mondo).
Il libro si chiude con una poesia, Sarete il mio futuro, nella quale il nostro poeta esprime la sua gioia al pensiero che qualcosa di lui sopravviverà, attraverso i nipoti, sulla terra dopo la sua morte: “Non morirò del tutto. / Vedrò la luce con i vostri occhi, / i colori, le forme, / le tante meraviglie strepitose” (Sarete il mio futuro).
Ed è questo un pensiero consolante, che rasserena il suo animo e lo riconcilia con la vita, al di là di ogni affanno e ogni pena. Con esso Domenico Defelice chiude un libro scritto con pienezza di cuore, ma anche con quella scioltezza e con quel gusto della parola poetica, franca e disinvolta, che caratterizzano da sempre le sue raccolte di versi.
Liliana Porro Andriuoli
DOMENICO DEFELICE: A RICCARDO (e agli altri che verranno) - Ed. Il Convivio, Castiglione di Sicilia, 2015, € 10,00.
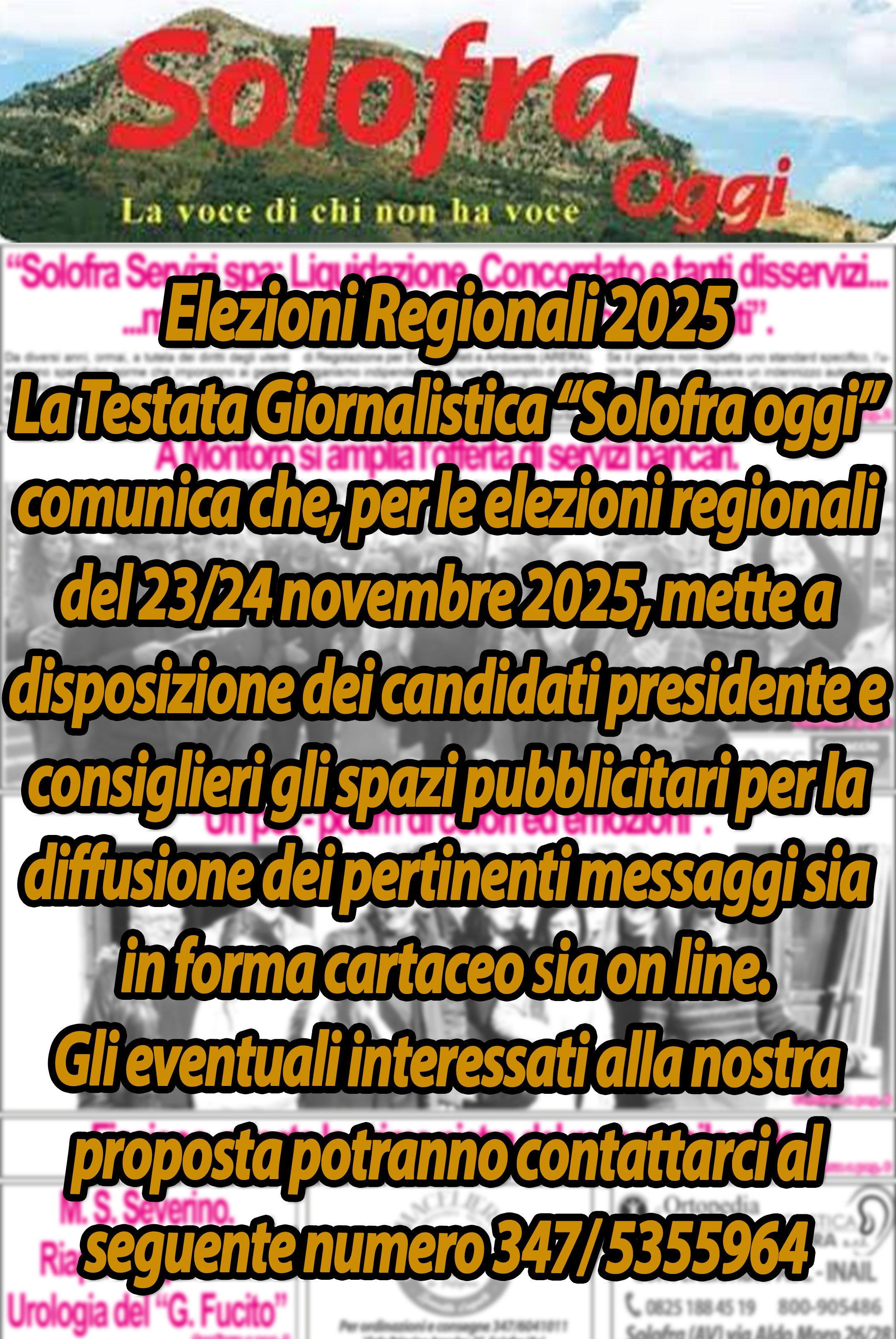



.jpg)