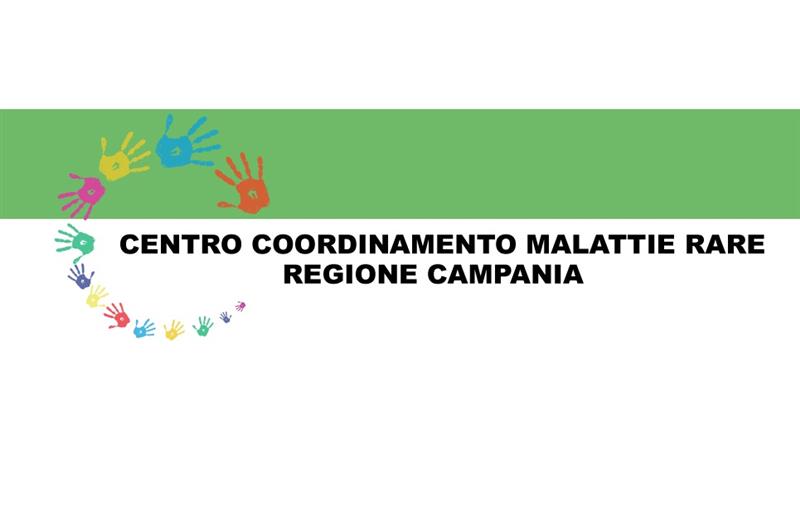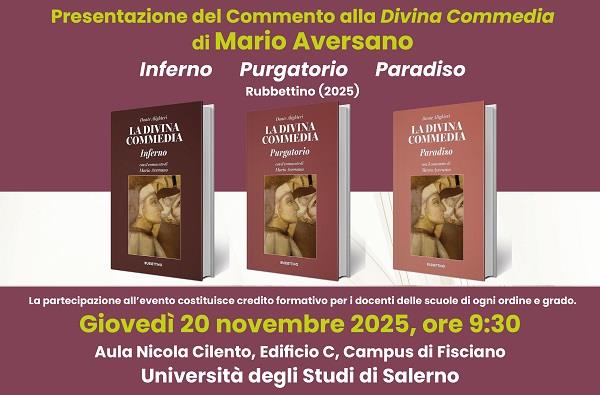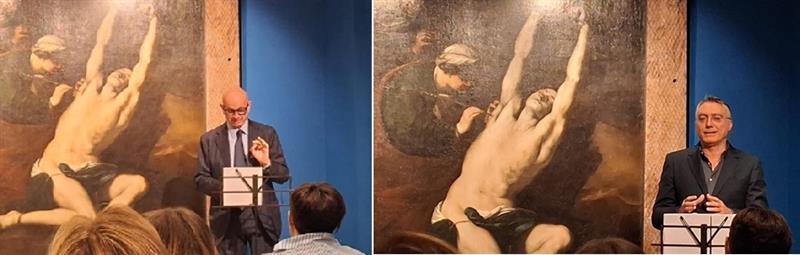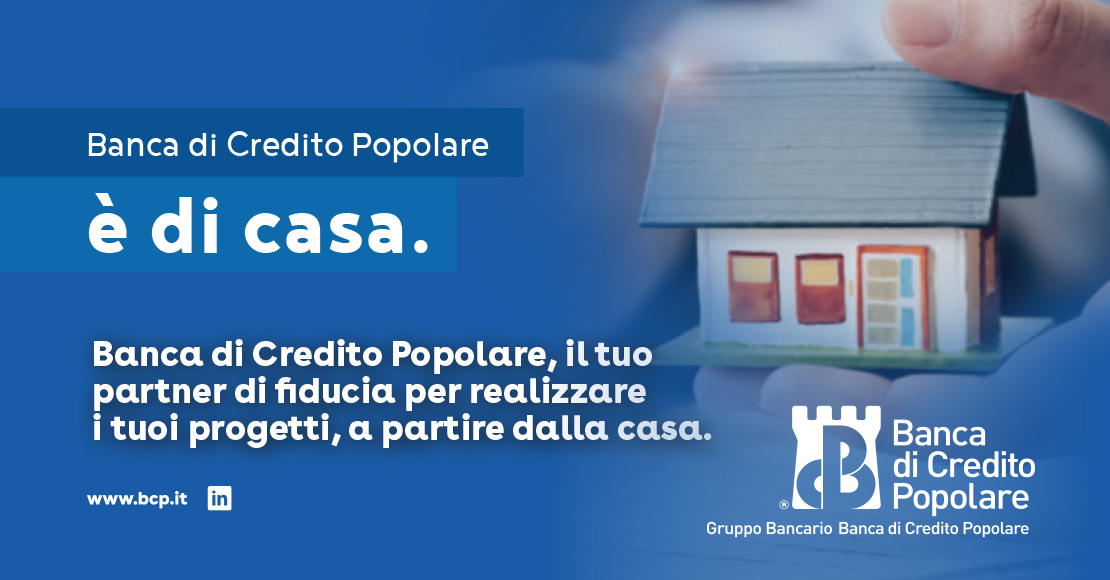Un duplice anniversario
Nei prossimi giorni ricorreranno due anniversari importanti: quelli della morte di Pasolini ed Eduardo De Filippo.
Due personalità eminenti della cultura italiana del Secondo Dopoguerra, morte dopo aver vissuto esistenze diversissime, ma avendo dato un contributo essenziale allo sviluppo della letteratura e del teatro.
Entrambe furono, certo, controcorrente: Pasolini ha incarnato il modello dell’intellettuale impegnato, fuori dal coro e dalle opposte Chiese che, in quel momento, erano rappresentate dalla Democrazia Cristiana, di cui mise in evidenza la corruzione, e dal Partito Comunista, da cui venne allontanato per la sua conclamata omosessualità.
Regista, scrittore, pubblicista, giornalista, sociologo: era la quinta essenza della poliedricità culturale, che lo aveva portato a vivere la propria condizione privata nella più assoluta serenità, visto che aveva confessato la natura omosessuale in un’Italia bigotta, che invero non era in grado di capire chi si dichiarasse “diverso” dal comune cliché.
Egli fu, inoltre, colui che mise in evidenza, già negli anni Cinquanta, come il PCI e la DC fossero molto più simili di quanto non volessero far intendere agli elettori: infatti, il trattamento, che gli riservò il Partito Comunista, quando venne acclarata la sua diversità sessuale, dimostrava quanto i due partiti, che erano al Governo e all’opposizione, fossero molto più simili di quanto essi stessi non si sforzassero di apparire.
D’altronde, Pasolini fu un comunista atipico, dato che viveva la fede cattolica lontano dai dogmi dell’ateismo marxista e, soprattutto, aveva come suo punto di riferimento sociale il sottoproletariato urbano e non gli operai sindacalizzati.
Pertanto, egli era il difensore strenuo di un mondo pre-industriale, che mal si conciliava con un’ideologia, come quella social-comunista, nata per difendere le classi che emergevano dall’industrializzazione dell’Ottocento e del Primo Novecento.
Un Pasolini, perfino, apparentemente reazionario era quello - invece - più genuinamente comunista, dal momento che aveva capito che il ceto, che meritava di andare tutelato, non era il proletariato, ampiamente difeso dal PCI e dal sindacato, ma quelle anime morte, per dirla alla Gogol, che vagavano nelle periferie delle metropoli italiane, ormai fuori tempo e fuori contesto storico rispetto all’Italia del boom economico.
Esse, infatti, potevano avere una ragione di esistenza in una società contadina, che invece andava progressivamente sparendo, superata da un processo industriale, che in Italia era stato viepiù indotto dalle mode consumistiche importate dall’America dopo la Guerra.
Proprio, quelle anime morte furono la causa della sua morte violenta, dal momento che chi ne commissionò l’uccisione, assaldò un ragazzo di strada per uccidere il poeta di origini friuliane, sapendo bene che Pasolini non avrebbe detto di ‘no’ a qualche ora di compagnìa con giovani, che sarebbero stati perfetti protagonisti di un suo romanzo o film.
L’altro grande scrittore, di cui si commemora l’anniversario della morte, è Eduardo De Filippo, l’unico artista italiano moderno, che si ricorda solo in virtù del suo nome di battesimo, come accade per Dante.
Troppe volte diffamato per un pirandellismo più di facciata che sostanziale, il drammaturgo napoletano è il volto del teatro italiano, visto che, nel caso delle sue opere, l’espressività del viso dell’attore non è disgiungibile dalla grandezza della sua scrittura, unica perché capace di mediare fra il napoletano di Scarpetta (padre naturale, ma non artistico in senso stretto di De Filippo) e l’italiano della tradizione aurea della letteratura del Novecento.
Pirandello, Freud, Scarpetta, Molière, Ionescu sono i punti di riferimento di un autore, che, sin dai primi anni Cinquanta, non è mai stato il cantore di una Napoli decadente ed oleografica, ma già si atteggiava come il grande artista sprovincializzato, che poteva misurarsi sui palcoscenici di mezzo mondo, in compagnìa del fratello Peppino e della sorella Titina, che possedevano il mestiere della recitazione in maniera altrettanto brillante quanto il fratello più noto.
Attraverso il ricordo di questi due grandi artisti, vogliamo anche evidenziare il ruolo che due città - Roma ed, appunto, Napoli - hanno avuto nella formazione di Pasolini ed Eduardo, per cui essi sono i corifei di sensibilità cittadine che, forse, esprimono un grado di originalità unico in Italia, perché il bagaglio di immagini e cultura, che portano con sé, deriva anche dal contesto urbano delle due metropoli del Centro-Sud.
Nasceranno in futuro nuovi Pasolini e De Filippo?
Crediamo di no, ma siamo fermamente convinti che essi continueranno ad ispirare chi non ha una visione meramente autoreferenziale della cultura e dell’impegno intellettuale.
Rosario Pesce
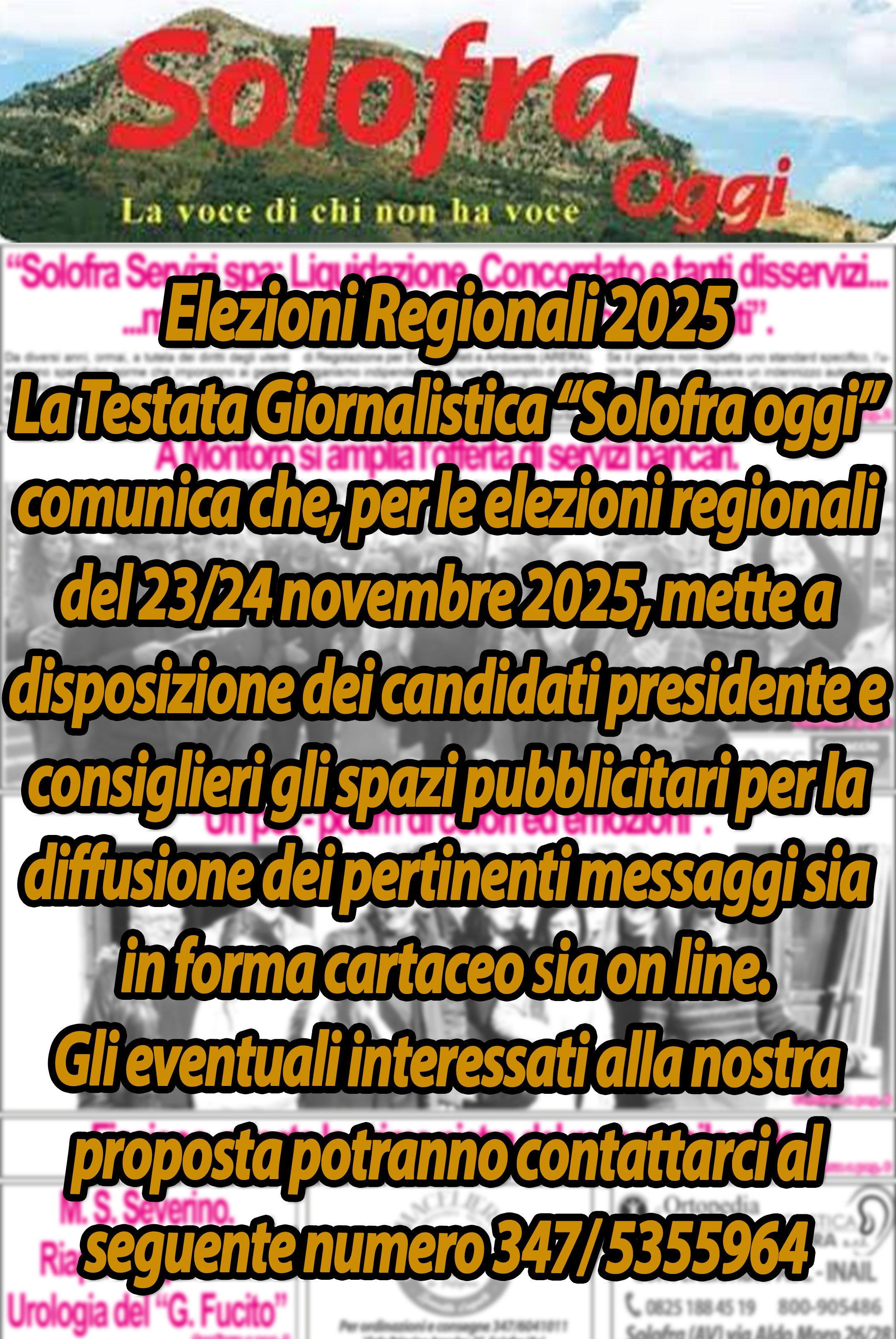



.jpg)