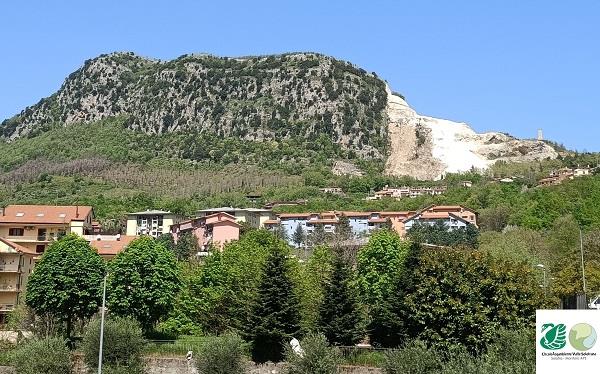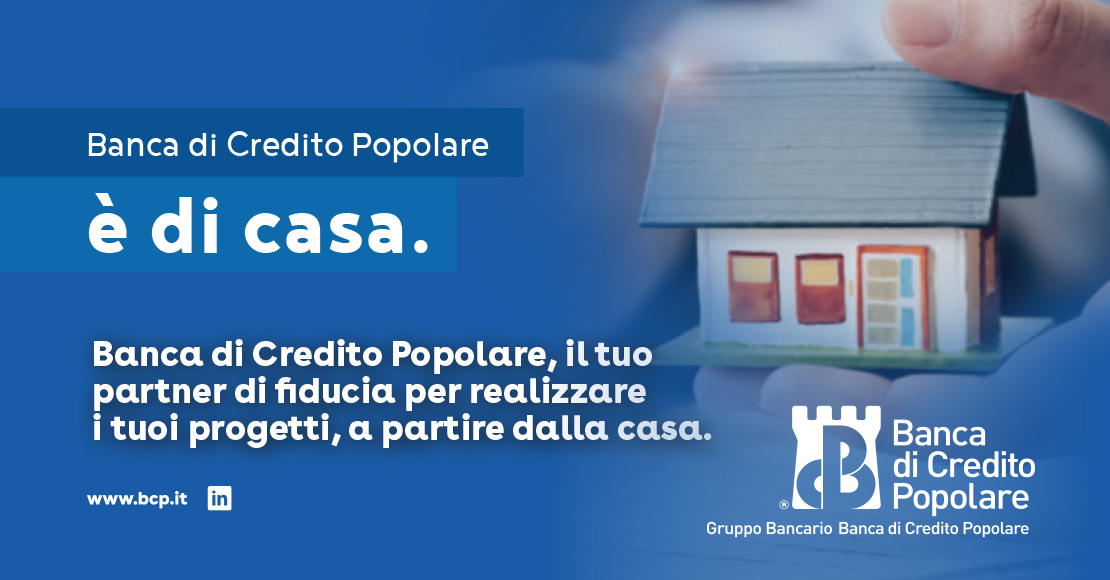Una data importante
23 novembre 1980
23 novembre 1980: una data importante, che ha segnato una trasformazione fondamentale del Mezzogiorno d’Italia, per effetto di un evento funesto, quale fu il terremoto che colpì, soprattutto, le tre province di Avellino, Salerno e Potenza, determinando circa tremila morti ed un numero ancora più alto di feriti.
Quel fatto tragico, consumatosi nel pomeriggio di una calda domenica autunnale, cambiò il volto urbanistico di interi paesi, distrutti dalla furia omicida della scossa sismica e ricostruiti ex-novo grazie ai copiosi investimenti pubblici, veicolati da una legislazione ad hoc, che comportò un afflusso finanziario, in Campania e Basilicata, così rilevante da non essere paragonabile a nessun altro accadimento della precedente storia italiana.
Il danaro, che arrivò, naturalmente non sempre fu speso in modo razionale ed efficiente: talora, esso andò, finanche, a soddisfare gli appetiti famelici della criminalità meridionale, che non si lasciò sfuggire l’affare del secolo, dal momento che l’intera compagine di Governo - sia democristiana, che socialista - fece a gara per finanziare, con la legge 219, diversi progetti, alcuni dei quali poi si sono dimostrati, tragicamente, fallimentari.
L’attenzione nazionale, che ricevette il Sud nel corso degli anni ’80, fu davvero unica, anche se poi fu ripagata a caro prezzo nel decennio successivo, dal momento che la nascita della Lega e della sua propaganda anti-meridionale, negli anni ’90, fu dovuta agli errori fatti in Campania ed in Basilicata ed allo sperpero di ingenti ricchezze pubbliche, che ne conseguì.
Invero, la ricostruzione non fu, però, costellata solo da ombre: se una parte di cittadini meridionali decisero di emigrare, dopo aver assistito alla distruzione dei Comuni, dove erano nati e cresciuti, molti altri accettarono la scommessa della ricostruzione ed, in particolare, intuirono quanto fosse opportuno avere la giusta elasticità mentale per cambiare mestiere e modus vivendi.
Infatti, dopo il terremoto, era inevitabile che il Sud non potesse più continuare ad essere quello che era stato per un secolo circa, dopo l’Unità nazionale: vennero finanziati alcuni piani di industrializzazione, che hanno avuto il merito di aver portato le genti meridionali a conoscere compiutamente, sul loro territorio, le conseguenze positive e negative dell’impresa moderna, dato che, fino ad allora, tutti quei centri, interessati dal sisma del 1980, avevano costruito le loro modeste fortune economiche su di un’agricoltura ed una pastorizia di mera sussistenza.
Evidentemente, divenire dall’oggi al domani operai, dopo che - per decenni - si era stati contadini o pastori, non fu cosa facile per moltissimi Meridionali, che subirono il contraccolpo psicologico di un cambio di mentalità, che, per essere effettivamente maturo, avrebbe dovuto stratificarsi nel corso di diverse generazioni, non bastando in tal senso né pochi anni, né un evento tragico – quale fu, appunto, il terremoto – che, in una decina di secondi, spazzò via numerosissime storie di comunità ed individui.
Un’altra luce fu, certamente, frutto dell’evento funesto del 1980: una classe dirigente, comunque preparata, riuscì ad affermarsi all’interno dei partiti di Governo, per cui, nel giro di pochissimo tempo, essa assunse il controllo dello Stato italiano, occupando posizioni di potere, davvero, significative.
Certo, al suo interno, non tutti esibivano il medesimo grado di competenza ed onestà, ma non si può negare che quello fu un momento straordinario di elaborazione programmatica per il Sud e per il Paese nel suo complesso, tanto più vista la classe politica, proveniente per lo più dalle fredde terre brianzole, che invece si sarebbe affermata negli anni ’90, dopo la caduta della I Repubblica.
Quest'ultima, infatti, rispetto a quella precedente, non si è segnalata né per qualità maggiori, né per un atteggiamento più pronunciato di attenzione verso il Bene comune.
Non si può, dunque, non rimpiangere un ceto di amministratori che, nonostante gli errori commessi, hanno offerto un contributo qualificato per l’avvio della soluzione della questione meridionale, dal momento che il sisma dell’Irpinia e della Lucania non faceva altro che riaprire una ferita prodottasi all’indomani del 1861, quando il Sud si scoprì depauperato delle sue principali risorse, umane ed economiche, per effetto delle politiche di ladrocinio messe in essere, nella seconda metà del XIX secolo, dai Governi scellerati della Destra Storica e della Sinistra Monarchica, molto più attenti alle sorti della grande industria del Nord che non a quelle della più debole agricoltura meridionale, ancora nelle mani di latifondisti e mafiosi.
Celebrando l’anniversario del terremoto, si ricorda una pagina triste della nostra storia, che però ha conosciuto anche momenti esaltanti, perché le genti del Sud, negli anni della ricostruzione post-sisma, hanno mostrato un ardore ed un anelito di crescita, che oggi invero loro difetta, forse perché disilluse da oltre trent’anni di cattiva gestione, che ha messo in ginocchio non solo le risorse produttive, ma soprattutto quel sentimento di riscatto, che invece mai dovrebbe mancare in chi parte da una condizione di indubbio svantaggio socio-economico rispetto al proprio simile.
Rosario Pesce



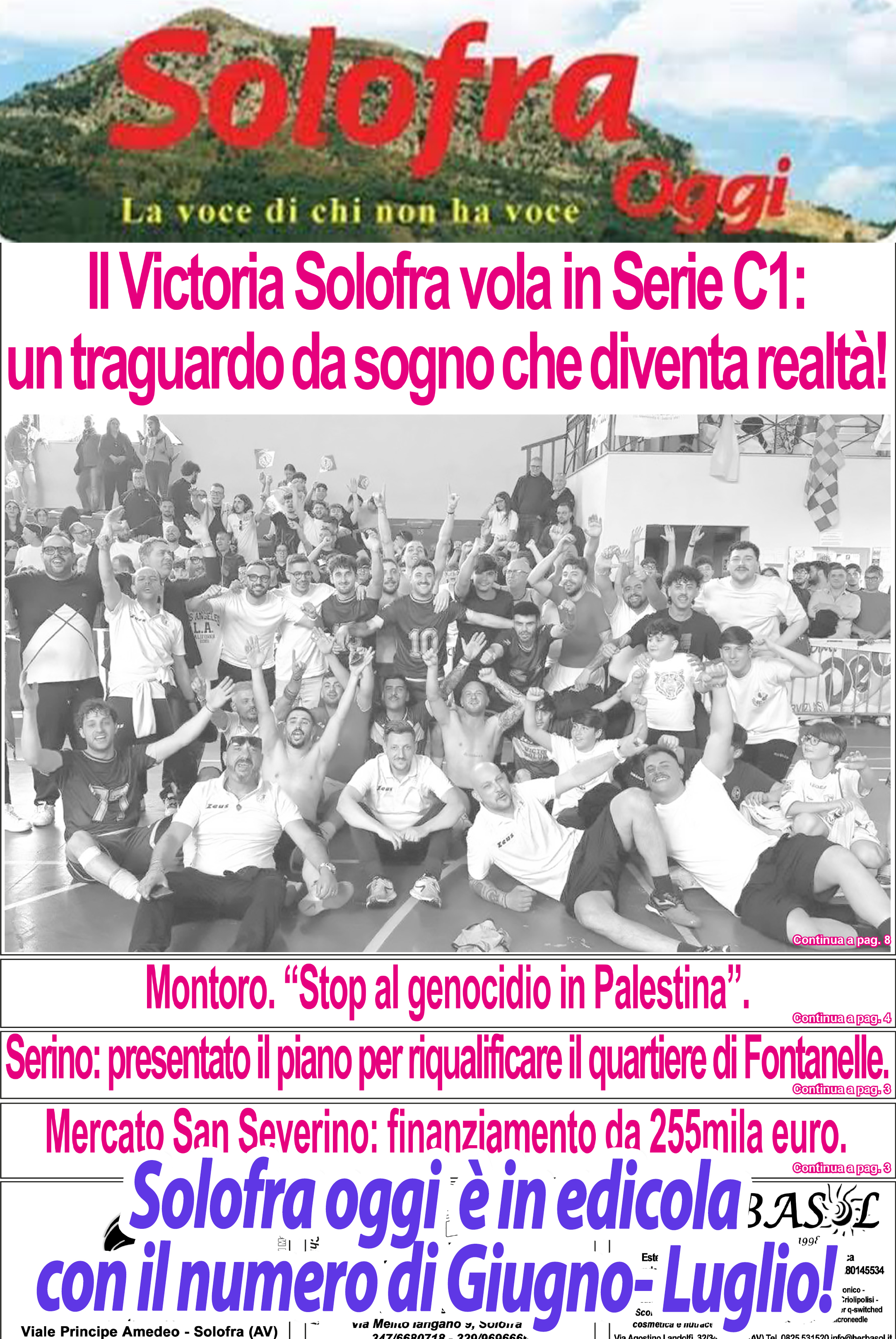
.jpg)