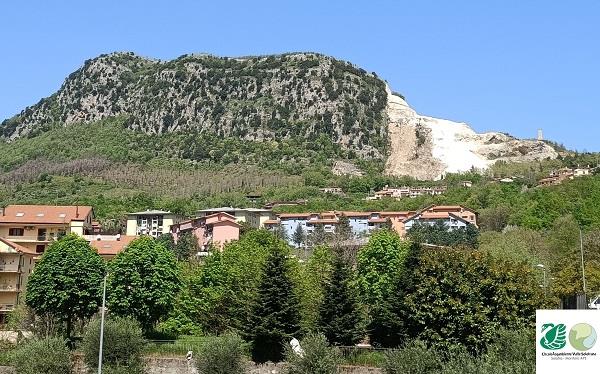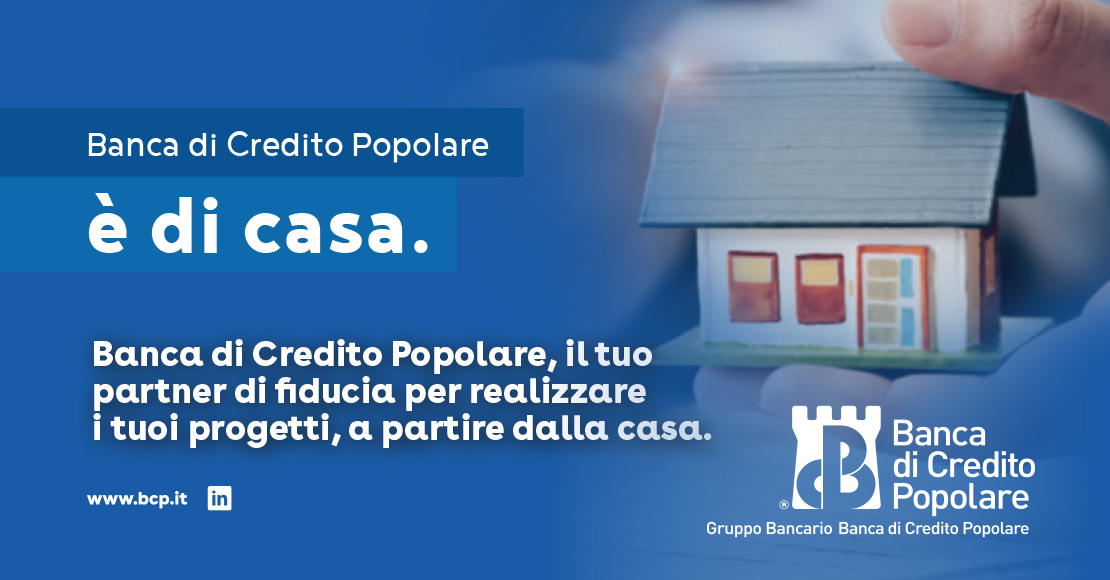La tutela del patrimonio artistico tra profitto e storia
Fa discutere molto la proposta di un archeologo, che ha lanciato l’idea di intervenire in modo drastico nel restauro del Colosseo, coprendo la parte interrata, che oggi – come tutti sanno – è a vista.
Infatti, Manacorda – questo è il suo nome – propone di ripristinare il piano dell’arena, esistito fino all’Ottocento, così da non rendere più visibile dagli spalti il livello sotterraneo, che è una delle attrattive dell’Anfiteatro Flavio.
L’idea, evidentemente, affonda la sua ragion d’essere in una logica di sfruttamento intensivo, da un punto di vista commerciale, di un bene storico che rappresenta il simbolo dell’antica Roma nel mondo intero.
Infatti, dividendo con un solaio, realizzato ex-novo, il piano emerso da quello infossato, di fatto si creerebbero due musei archeologici in uno, visto che si potrebbe imporre, finanche, un doppio ticket, distinto per ciascun piano, che il turista andrebbe a visitare.
Non si può non dire che la proposta abbia il suo fascino da un punto di vista economico, tanto più in un momento - come quello attuale - in cui l’ingresso dei privati nella gestione dei beni di interesse artistico, inevitabilmente, sollecita una logica commerciale, dapprima non esistente, per cui ogni occasione di creazione di profitto non può che essere vista con estremo favore da chi ha investito danaro non statale ed aspira, legittimamente, a potenziare le chance di rientro significativo dei capitali investiti.
Naturalmente, una siffatta logica deve misurarsi con quella della tutela pubblica del bene oggetto di interesse da parte dell’imprenditore, che - nel caso di specie - è il gruppo Della Valle.
Ormai, da molti decenni domina l’idea che il restauro di un sito archeologico o, comunque, del patrimonio artistico debba perseguire delle finalità di natura conservativa, per cui gli interventi devono essere volti al ripristino dei luoghi sic et simpliciter e non alla trasformazione, più o meno invasiva, del bene di cui si intende realizzare la manutenzione.
Orbene, creare un solaio fra gli spalti e la parte interrata del Colosseo, allo scopo di far rivivere l’arena, che non c’è più dall’Ottocento, appare un intervento che persegue fini assai diversi rispetto a quelli tipici del restauro.
Gli occhi dei turisti, anche di quelli che hanno visto l’Anfiteatro solo per televisione o su cartolina, sono ormai abituati ad immaginare l’Anfiteatro più importante d’Italia così come esso oggi si palesa, cioè un’unica costruzione verticale che non presenta nessun piano orizzontale in grado di dividere ed interrompere, dunque, il senso di continuità conferito dalla doppia circolarità degli spalti.
Pertanto, ripristinare lo stato ottocentesco dei luoghi è un’operazione discutibile sul piano della scienza e della tecnica del restauro, anche se sono comprensibili le ragioni economiche che possono sollecitare la creazione di due distinti spazi museali all’interno del medesimo manufatto antico.
Il Ministero, che ovviamente rimane il proprietario del bene, ha dato il via libera alla proposta di Manacorda, agendo dunque in sinergia con il soggetto privato, che trarrà grande beneficio dal ripristino dell’arena, visto che il piano superiore potrà essere utilizzato per l’organizzazione di eventi mondani ed artistico-ludici, mentre l’area sottostante potrà divenire spazio museale del tutto indipendente da quello immediatamente superiore, consentendo così di differenziare l’offerta museale, pur all’interno della medesima struttura.
Bisognerebbe, al di là della contingenza specifica del Colosseo, chiarire bene l’idea che le istituzioni hanno in materia di restauro e conservazione dei beni antichi.
Il modello, infatti, che promana dalla vicenda del Colosseo, consente di moltiplicare gli investimenti, in virtù dei profitti maggiori, che possono derivare da un aumento o differenziazione della destinazione d’uso dello spazio museale a disposizione, intaccando però convincimenti secolari in tema di conservazione archeologica.
Tra le ragioni del profitto e quelle della salvaguardia di un’opera d’arte, volta alla riduzione degli interventi trasformativi, quale strada va privilegiata?
Abituati a credere che l’arte viene prima del guadagno, forse riteniamo opportuno che il nostro patrimonio artistico venga musealizzato nella forma esteticamente più corretta, dato che lo spazio museale da tutelare deve essere il fine ed non il mezzo di operazioni aventi un segno ben diverso da quello della difesa, tout court, del manufatto storico.
È necessario, pertanto, che le ragioni dell’imprenditoria trovino il giusto compromesso con quelle dell’arte, se si vuol evitare che beni, che permangono comunque di proprietà dello Stato, diventino una mera occasione di guadagno per chi – in futuro – potrebbe, dopo aver ricostruito l’arena-solaio, ipotizzare di ripristinare gli spalti o la copertura esistenti ai tempi dell’antica Roma.
Ma, in quel caso, saremmo in presenza di un falso storico perfetto: storico appunto, ma soprattutto falso.
Rosario Pesce



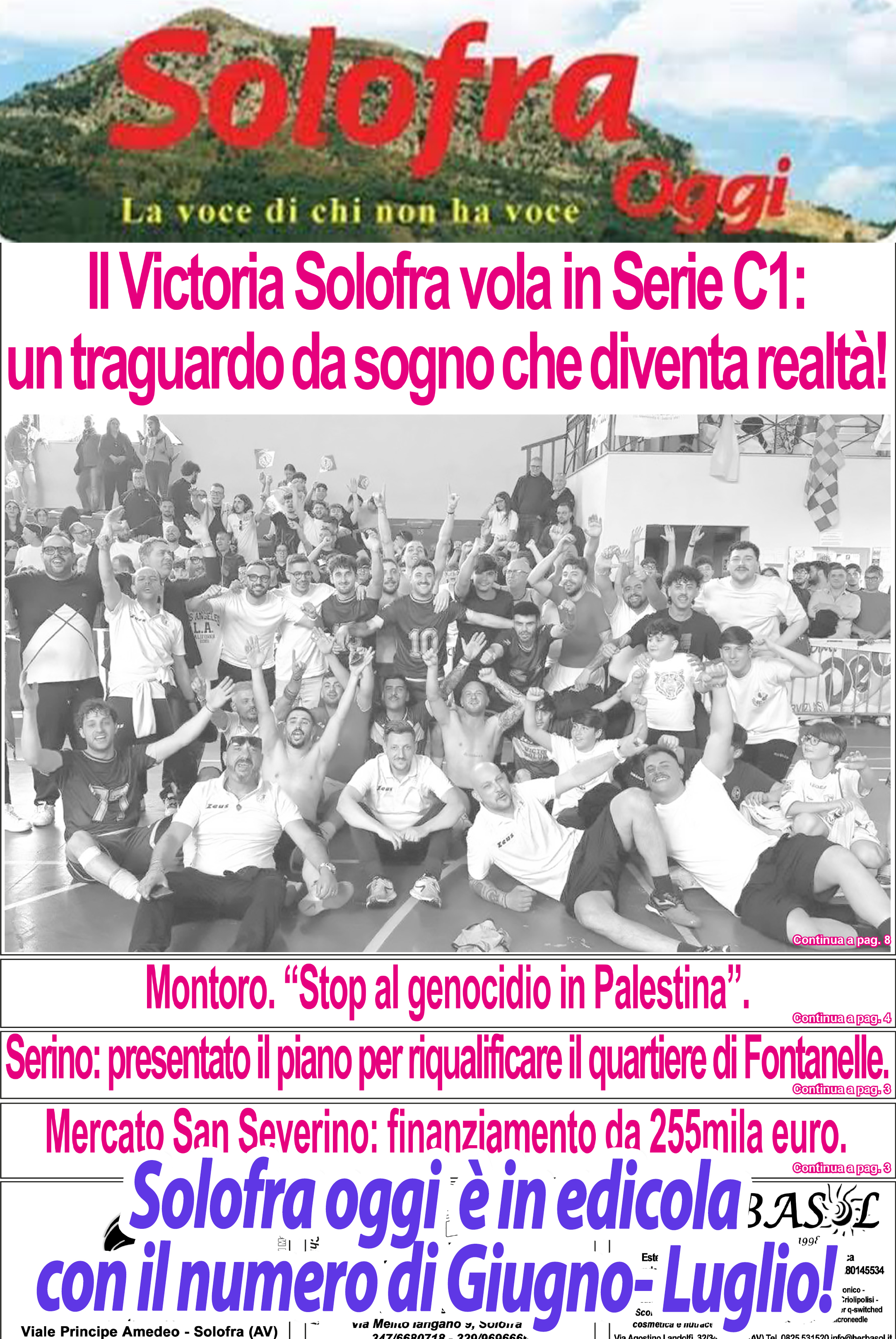
.jpg)