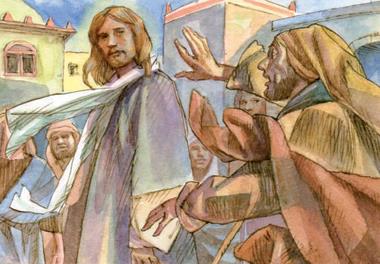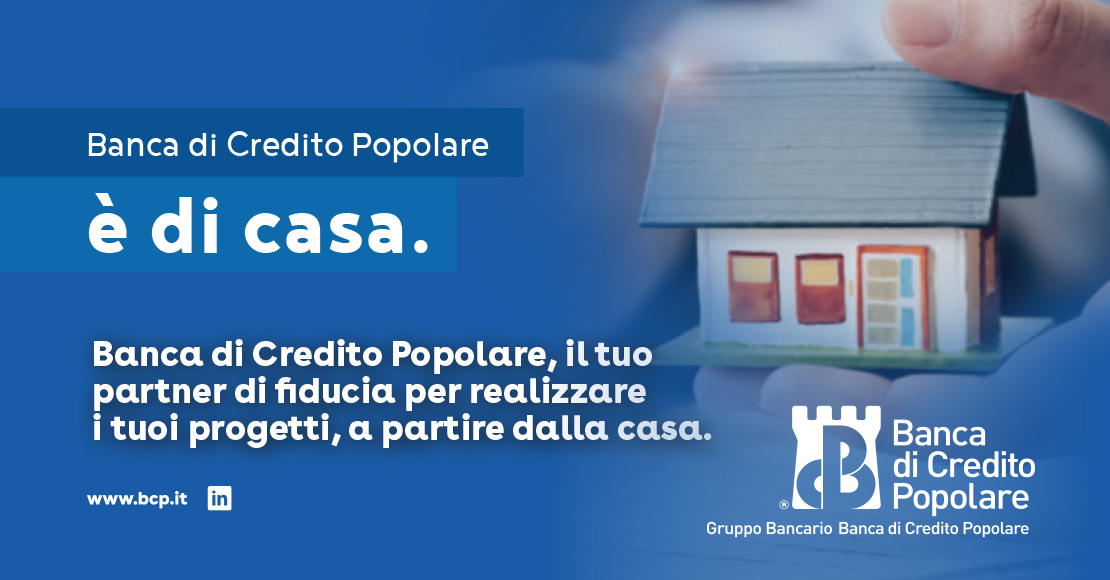Tempo Ordinario: Domenica 30 C
Non si tratta di “omelia”, ma di riflessioni che vengono dalla meditazione della Parola di Dio e che possono offrire spunti per la preghiera personale e l’omelia. Sono graditi suggerimenti per rendere più utili queste riflessioni
I - Luca 18,9-14 – 1. Gesù racconta la parabola non per insegnare come si deve pregare, ma per sottolineare alcuni atteggiamenti da imitare o da evitare nella preghiera. Egli parla per illuminare specialmente i farisei, perché si ritenevano giusti e mostravano disprezzo per gli altri (9 Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri), atteggiamento da evitare assolutamente nella preghiera e nella vita quotidiana. Egli parla di due persone, che vanno al Tempio, per eccellenza il luogo della preghiera, perché dimora di Dio: si tratta di un pubblicano e di un fariseo (10 Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano); i farisei avevano l’abitudine di pregare dappertutto, specie dove erano più facilmente visibili e potevano essere ammirati da più persone. (a) Il fariseo prega in piedi e muovendo le labbra, come facevano solitamente gli ebrei (11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé), e inizia benedicendo Dio, che spesso diventava anche un ringraziamento (O Dio, ti ringrazio 11); stavolta il fariseo ringrazia perché lui, per il suo impegno, non era come gli uomini comuni, che non osservavano la Legge di Dio nel settimo comandamento “non rubare” - e perciò erano ladri e ingiusti -, e nel sesto e nono “Non commettere atti impuri” e “non desiderare la donna o uomo di altri” – per cui erano adulteri -, e tantomeno era come il pubblicano, - che egli vedeva non lontano da sé –, grande peccatore perché lavorava per conto dei Romani, nemici occupanti (11 perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano). Inoltre ricorda con orgoglio a Dio che egli digiuna due volte la settimana (lunedì e giovedì), mentre era obbligatorio una volta all'anno, e pagava la decima di tutto, non solo di alcune cose obbligatorie (12 Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo). Riflettiamo che quest'uomo non ha la vera fede: crede che Dio sia un contabile, che prende nota delle opere buone ma non tiene conto degli atteggiamenti interiori delle persone, che sono fondamentali per dare valore alle azioni. Egli non riesce a prendere coscienza di essere un peccatore, che ha bisogno della misericordia di Dio; non si rende conto che il suo peccato fondamentale è proprio la superbia (il più grave che esista!), che lo porta ad attribuire a sé le buone azioni e non a Dio, dal quale proviene ogni bene; di conseguenza disprezza il prossimo, cosa che Dio non gradisce affatto, perché ogni uomo è a sua immagine. Questo tipo di preghiera offende Dio invece di onorarlo e non è utile per ottenere le sue grazie. (b) Il pubblicano prega in piedi per rispetto a Dio e per umiltà si tiene a distanza dall'altare; tiene gli occhi bassi e si batte il petto: si riconosce peccatore e chiede pietà a Dio, (13 Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”). Questo tipo di preghiera è graditissimo a Dio, perché l'uomo è peccatore e, quando si sente tale, assume un atteggiamento umile interiore ed esteriore alla presenza Sua (e degli uomini), perché sa che solo da Dio può avere il perdono e la riconciliazione. Non si interessa dei peccati degli altri, ma dei propri per ottenere la misericordia di Dio. Questo atteggiamento del pubblicano va imitato da parte nostra. Come è la nostra preghiera? E’ anzitutto ringraziamento a Dio per le grazie che ci dà nella sua bontà? E’ umile nel riconoscere le nostre colpe, giacché tutti siamo peccatori? Siamo coscienti che tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo esercitarla con gli altri per ottenerla da Dio per noi?
2. Il pubblicano fu reso giusto da Dio, che gli mostra la sua misericordia; il fariseo resta con la sua illusoria giustizia, e quindi con tutti i suoi peccati (14 Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato). Questo rovesciamento della situazione non è un capriccio o una vendetta di Dio, ma è la rivelazione della verità di ciascuno: chi si esalta illude se stesso perché attribuisce a se stesso i doni di Dio e non a Lui, come sarebbe giusto; e chi si umilia si comporta giustamente e può confidare nella misericordia di Dio (14 perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato). L’atteggiamento di umiltà del pubblicano dobbiamo alimentare in noi: nella nostra preghiera e in tutte le nostre attività, e anzitutto nei pensieri e sentimenti; invece dobbiamo assolutamente evitare gli atteggiamenti di superbia del fariseo, se vogliamo che Dio ci comunichi la sua santità e giustizia.
II - Siracide 35,15b-17.20-22 – (a) Dio è giudice che non fa preferenze di persone (15 il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone). Certamente non parteggia contro il povero (16 Non è parziale a danno del povero); anzi ne ascolta la sua preghiera quando è oppresso (16 e ascolta la preghiera dell’oppresso) o quando si tratta di un orfano o di una vedova, che sfogano nel lamento la sofferenza del cuore (17 Non trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento). La preghiera del povero arriva sempre fino a Dio, perché si ferma solo quando arriva a destinazione (21 La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata), si interrompe solo quando Dio interviene (21 non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto) e contenta i giusti, ristabilendo l'equità nei rapporti (22 e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità). Il povero deve avere e alimentare la sua fiducia nell’onnipotenza di Dio e nella sua infinita bontà, perché Egli è sempre disposto ad ascoltare chi è nel bisogno e nella sofferenza per l’infinita misericordia che lo caratterizza: Egli sa trovare una soluzione per tutte le difficoltà. D'altra parte Dio gradisce che ci rivolgiamo a lui come figli al Padre. Penso che tutti abbiamo fatto o facciamo esperienza di quante volte Dio interviene in nostro aiuto anche in modo sorprendente. (b) Anche chi soccorre i poveri è ascoltato da Dio con amore e la sua preghiera Gli è gradita ed è esaudita come quella dei poveri (20 Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi): i poveri sono accettati ed esauditi da Dio perché poveri e bisognosi, i ricchi sono esauditi perché assumono i sentimenti e il ruolo di Dio nell'aiutare il povero.
III - 2 Timoteo 4,6-8.16-18 – (a) Paolo rievoca la sua comparsa in tribunale a Roma, dove nessuno è venuto in suo aiuto, perché abbandonato da tutti (16 Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato): egli chiede perdono per gli amici – come Gesù pregò in croce per i suoi crocifissori e Stefano per i suoi lapidatori -, perché essi per colpa loro non si sono presentati a difenderlo (16 Nei loro confronti, non se ne tenga conto), ma sottolinea che comunque è riuscito a sfuggire alla morte, perché ha avuto con sé il migliore Difensore e Redentore, il Signore stesso, che gli ha dato forza e lo ha messo in condizione di completare la sua missione di annunziatore del vangelo, facendolo conoscere al centro dell'impero, persino forse nella corte imperiale (17 Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone), e davanti a Nerone. Paolo ha avuto fiducia in Dio e si è abbandonato a Lui e Dio gli ha risolto ogni problema di difesa. Facciamo anche noi come Paolo: affidiamo a Dio noi stessi; Egli sa guidare la nostra vita e le sue circostanze a nostro vantaggio molto meglio di come possiamo pensare e fare noi. (b) Comunque Paolo sa di essere al termine della sua vita terrena (6 Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita) e fa un bilancio di essa: la vita è una battaglia e lui l’ha combattuta bene; la vita è una corsa e lui è al termine di essa; l'importante è che abbia conservato fede, speranza e carità, che ci tengono uniti a Dio (7 Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede). Egli si aspetta dal Signore il giusto premio, che Egli darà a tutti coloro che aspettano con amore e desiderio la sua seconda venuta gloriosa (8 Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione). In quell'occasione il Signore gli darà la libertà definitiva e lo porterà salvo in cielo con lui a regnare per sempre (18 Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno). E conclude con un’acclamazione in onore di Gesù: a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen (18)! Anche noi preghiamo di poter affermare le stesse cose alla fine della nostra vita, affidandoci non alla giustizia distributiva di Dio, ma alla sua giustizia salvatrice, alla sua misericordia, che è infinita rispetto ai nostri peccati, che sono limitati. Per questa stessa misericordia infinita confidiamo che Egli ci accoglierà alla fine della vita e ci introdurrà nel suo Regno eterno.
EUCARESTIA. Di fronte a Gesù siamo tutti uguali, adesso nell’incontrarlo nell’Eucarestia e alla fine della vita al suo giudizio. Tutti siamo uguali anche nell’essere peccatori e come chiediamo perdono tutti insieme all’inizio della Messa per i nostri peccati, così alla fine della vita faremo appello alla sua misericordia perché ci ammetta alla visione facciale, dopo che lo abbiamo incontrato tante volte nella fede. Invochiamo la Vergine SS. e S. Giuseppe, gli Angeli Custodi e i Santi Patroni perché intercedano per noi e ci ottengano la vita eterna ora e nell’eternità.
mons. Francesco Spaduzzi, francescospaduzzi@virgilio.it




.jpg)