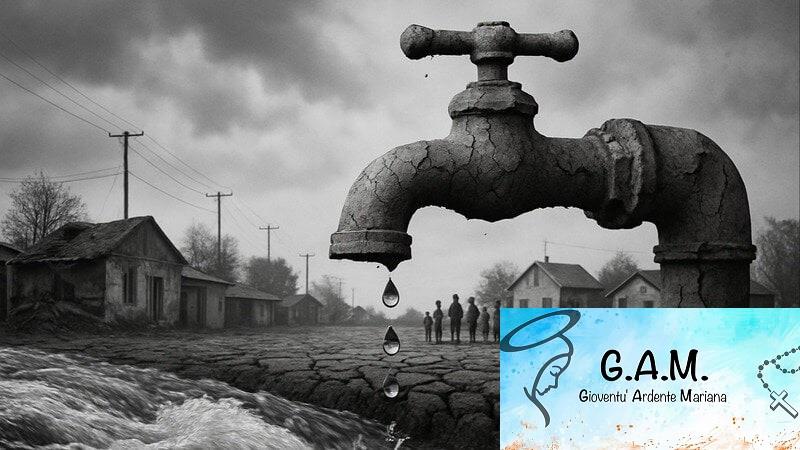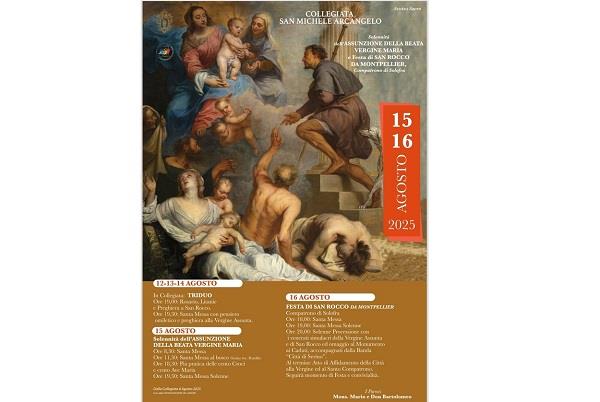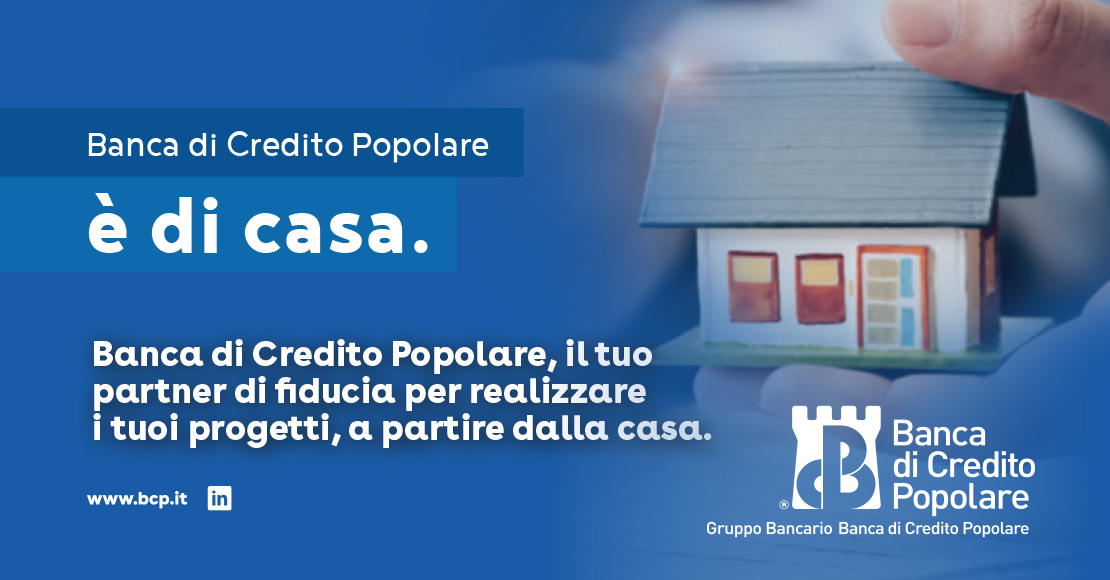L’economia è femmina! Parola chiave #donne
In Italia, le donne sono più degli uomini, hanno un’aspettativa di vita più lunga e possono
contare su un miglioramento significativo della loro presenza nei vertici politici, istituzionali e
delle organizzazioni sociali, anche a seguito della mobilitazione delle donne e dell'impegno
costante della CGIL. Eppure, ancora è lungo il cammino per l’uguaglianza di genere nelle
opportunità occupazionali e salariali – e di conseguenza anche pensionistiche – considerando
soprattutto le maggiori difficoltà causate alle donne dalla precarietà nel lavoro, dalla minore
continuità lavorativa nell'arco di vita e gli ostacoli alla progressione della carriera, dalle enormi
difficoltà di conciliazione tra vita familiare e contesto lavorativo, acuite dalle mancanze dei
servizi.
La crescita potenziale. Diverse fonti, anche istituzionali, spesso hanno elaborato modelli di
calcolo econometrico capaci di simulare la crescita di un paese nell’ipotesi di un maggiore e
migliore impiego delle risorse femminili, in particolare, dal punto di vista occupazionale. La
Banca d’Italia, in uno studio del 2013, sostiene che “un maggiore accesso femminile al
mercato del lavoro, che ne innalzasse il tasso di occupazione all’obiettivo di Lisbona (60 per
cento) si assocerebbe «meccanicamente» a un PIL più elevato del 7 per cento”. Il PIL
italiano, nonostante la modesta variazione positiva (1%), nel 2016 si trova esattamente 7 punti
sotto il livello pre-crisi (2007).
L’occupazione potenziale. La crescita potenziale in caso di uguaglianza di genere, dunque, viene
calcolata immaginando che il sistema economico-produttivo disponga di un numero di posti di
lavoro in cui impiegare donne in età di forza lavoro (15-64 anni) analogo a quelli degli uomini
occupati nello stesso periodo. Se, invece, utilizzando l’indagine Istat sulle forze di lavoro, si
parte dal numero di occupati di genere maschile e si ipotizza di colmare la forbice
occupazionale femminile (-28,3%), il contributo in termini di posti di lavoro potenziali
ammonterebbe a oltre 10 volte il differenziale di occupati dicembre 2016 / dicembre 2007.
Lo stesso ragionamento vale per il tasso di disoccupazione: se in Italia si attivassero e si
creassero tanti posti di lavoro per le donne quanti oggi ce ne sono per gli uomini (in termini di
volume occupazionale), il tasso di disoccupazione generale scenderebbe di oltre 6 punti
percentuali, addirittura al di sotto il livello pre-crisi (dall’11,9% al 5,8%).
2
Naturalmente, per chiudere il #gap e raggiungere tali risultati macroeconomici, sia in termini
occupazionali che di incremento del PIL, potrebbero occorrere periodi più lunghi di quelli
confrontati (non un mese o un anno), ma di sicuro inferiori a quelli trascorsi dall’inizio della crisi
senza mai recuperare i livelli precedenti.
Gender pay gap. Una delle statistiche più importanti riguarda il differenziale salariale fra
uomini e donne. Secondo un’indagine Istat del 2016, il #gap fra le retribuzioni medie lorde
orarie dei lavoratori e quello delle lavoratrici femmine nel settore privato è pari al 12,2 per
cento. Per la prima volta dal 2014, il tasso di variazione delle retribuzioni di fatto torna negativo
(-0,1) nell’ultimo trimestre 2016, nonostante la variazione positiva delle retribuzioni
contrattuali, benché in linea con la deflazione registrata in corso d’anno. Se, però, venisse
compensato il divario salariale di genere le retribuzioni nominali aumenterebbero di 5,5 punti
percentuali, più del doppio del tasso di variazione che occorrerebbe per ripristinare il ritmo di
crescita dei salari di fatto negli anni pre-crisi (2,6 per cento).
GLOSSARIO #GAP
Il termine inglese #gap letteralmente vuol dire «apertura» o «distacco» e viene usato in
economia con il significato di «divario» o «dislivello», per indicare lo squilibrio fra aggregati
micro e macro economici nei confronti internazionali o tra territori (es. Nord e Sud del paese),
piuttosto che nel raffronto tra variabili socio-demografiche come i generi o le generazioni.
L’uso del termine gap è divenuto più frequente all’interno delle istituzioni economiche nel
calcolo della crescita del PIL potenziale, ovvero del cosiddetto output gap: differenza fra
produzione potenziale o di pieno impiego e produzione effettiva. Va ricordato che proprio sulla
base dell’output gap si misura la sostenibilità delle finanze pubbliche secondo i parametri
europei (vedi “pareggio di bilancio strutturale” come obiettivo di medio termine, nel Fiscal
Compact).



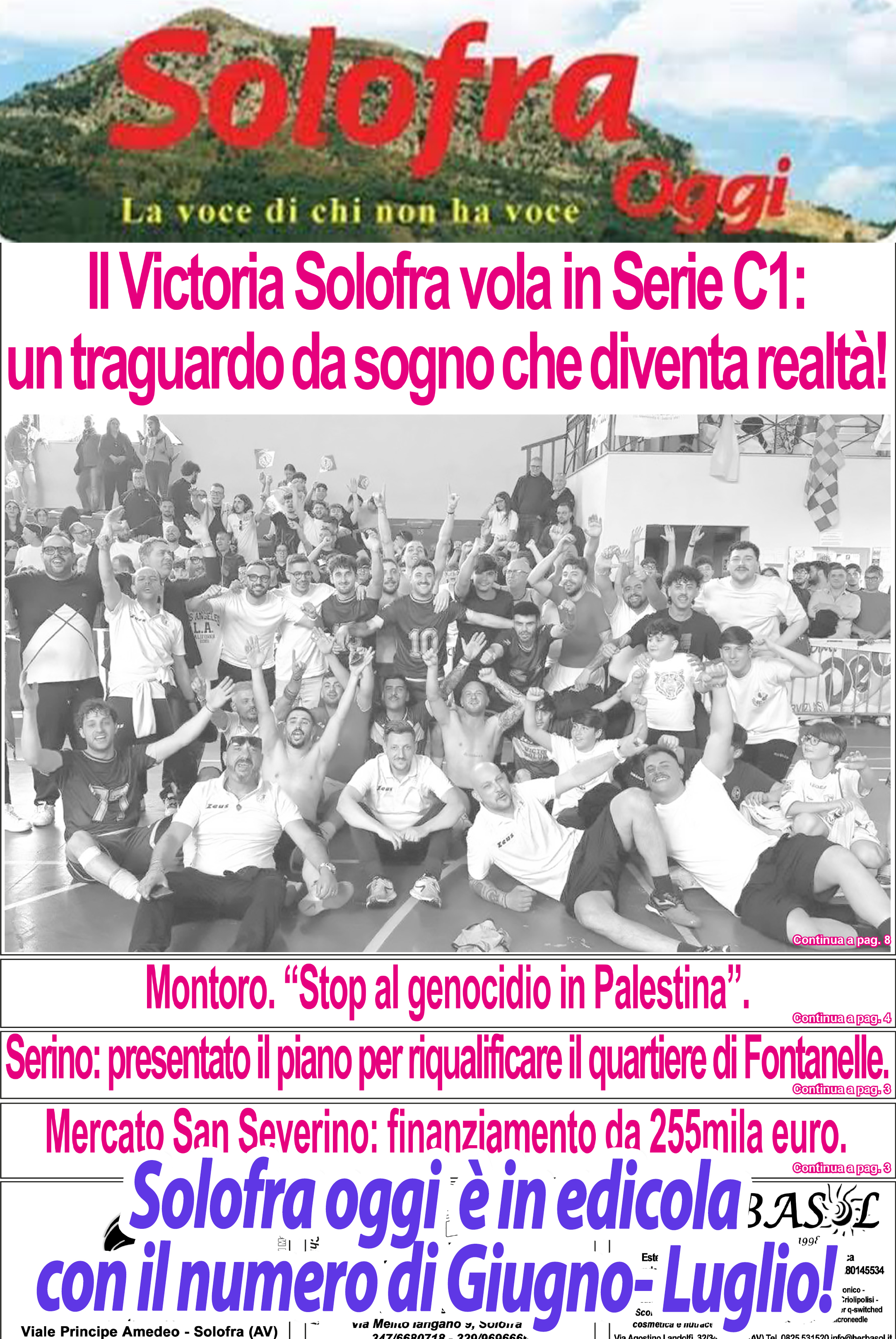
.jpg)