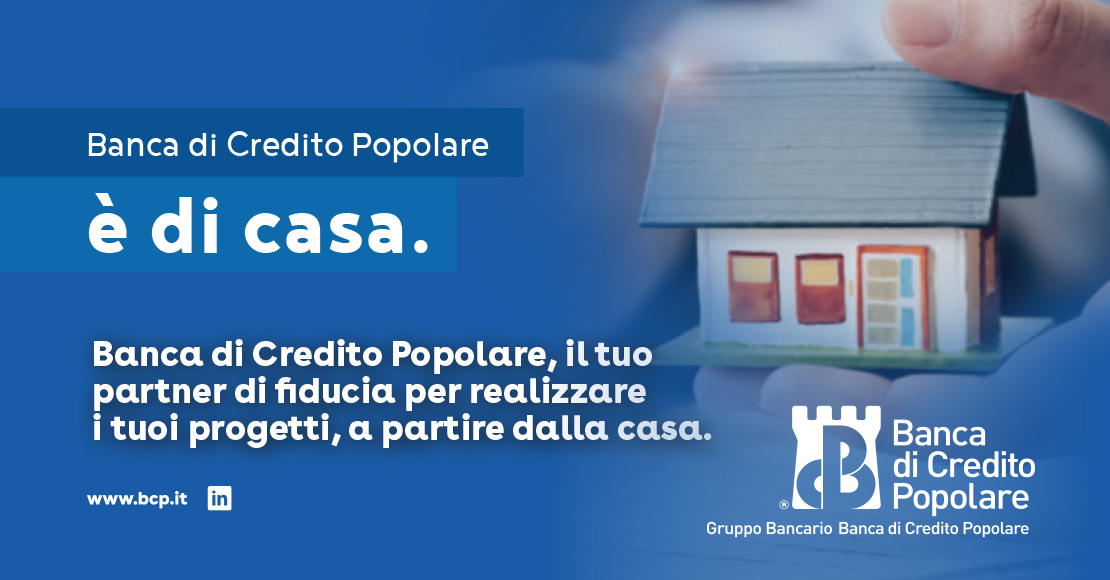Anche quest’anno la celebrazione del Giorno del ricordo rischia di oscurare le gravissime colpe del
“ Quella volta la sera non veniva e pareva che non vi sarebbe stata nemmeno la notte, dato che sopra le case il cielo era rosso come se fosse intriso di sangue. Nell’aria c’era odore di fumo …Perché hanno incendiato il Narodni Dom” ( B. Pahor, “Il rogo del porto”).
Trieste, 13 luglio 1920. Al termine di una giornata di tensione, una masnada di fascisti, capitanati da Francesco Giunta (che poi diverrà segretario del PNF), insieme ad altri elementi dell’oltranzismo nazionalista, dà l’assalto al Narodni Dom, il più importante complesso culturale sloveno. Ben presto l’attacco sfocia in un incendio. Sul campo restano morti, feriti e rovine, non solo materiali. Boris Pahor, l’autore del brano citato, è forse l’ unico testimone ancora in vita di quella giornata, che segna l’esordio cruento ed efferato del fascismo di frontiera. Sloveno di Trieste, classe 1913, forse il maggiore scrittore di lingua slovena (solo da pochi anni tradotto e pubblicato in Italia), Pahor ha attraversato nella sua interezza il cuore di tenebra del Novecento, dapprima vittima della repressione fascista, quindi di quella nazista, subita attraverso l’ esperienza del Lager e rievocata in quello che è considerato il suo capolavoro, “Necropoli”. Il fuoco che domina la descrizione di Pahor è un elemento caratterizzante del fascismo delle origini: nel fuoco era sfociata la primissima azione armata dei neonati fasci di combattimento, a Milano, nell’aprile 1919. Anche allora una gazzarra nazionalista era culminata, con la complicità di arditi e militari, in un atto di piromania omicida, contro la sede dell’Avanti!, organo del Partito Socialista, che Mussolini aveva diretto fino al clamoroso voltafaccia interventista dell’ottobre 1914. Il ricorso ossessivo e indiscriminato al fuoco era certo inscritto in un’economia della violenza, in quanto capace di coniugare la massima capacità distruttiva con un impiego di forze limitato, ma rispondeva nel contempo a oscuri rituali di purificazione, che nel fuoco individuavano lo strumento per la rigenerazione e la riconsacrazione dello spazio pubblico profanato dagli “elementi antinazionali”.
“Di fronte a una razza come la slava, inferiore e barbara, non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. Io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani”. Non si può dire che Mussolini non sia stato coerente con questa sua inquietante enunciazione del 1920. L’ antislavismo attraversa infatti l’intero arco del Ventennio. Anzi, già prima dell’ avvento del fascismo-regime, esso ne rappresenta un tratto identitario ed è parte costitutiva della sua ideologia. Il dittatore sceglierà non a caso proprio Trieste per “lanciare”, nel settembre 1938, le leggi razziali e la politica antiebraica. Antislavismo, antiebraismo e colonialismo razzista formano un’ unica sequenza storico-politica, propedeutica all’edificazione dell’impero e dello stato totalitario. Il già citato Boris Pahor in un’ altra sua opera, “Qui è proibito parlare”, descrive in tutta la sua violenza il disegno di annientamento culturale portato avanti dal regime nei confronti della minoranza slovena: distruzione delle scuole e dei libri in sloveno, divieto di parlare la lingua, italianizzazione forzata dei cognomi e dei toponimi, innumerevoli vessazioni nella vita quotidiana.
Poi, dopo l’attacco simultaneo delle due potenze dell’Asse dell’aprile 1941, lo smembramento del Regno di Jugoslavia e l’ annessione all’Italia di una parte del suo territorio, si passerà al genocidio vero e proprio. Il totale delle vittime (fra rastrellamenti, operazioni antipartigiane, incendi di interi villaggi e morti nei campi di concentramento), toccherà le 250.000 unità, quasi tutti civili. Popolazioni slave d’oltreconfine ed “allogene” saranno accomunate dal drammatico destino della detenzione nei campi di concentramento. In alcuni di essi, come quello, famigerato, di Arbe, l’ indice di mortalità sarà pari a quello registrato nei campi nazisti. Come rileva Carlo Spartaco Capogreco ( “I campi del duce. L’internamento civile nell’ Italia fascista”), “ Il raffronto tra i campi italiani della Jugoslavia e quelli della Libia sembra avvalorare ulteriormente quell’impronta ‘coloniale’ dell’aggressione fascista alla Jugoslavia (…) Oltre alle tende dei campi, anche i reticolati fatti erigere dal generale Roatta attorno alle principali città slovene (trasformate esse stesse, di fatto, in campi di concentramento), ricordano quelli issati negli anni Trenta al confine libico-egiziano” (pp. 140-141). Colonialismo, razzismo, genocidio prima culturale e poi fisico. Questo, in sintesi estrema, il bilancio della politica dell’ Italia fascista nei confronti delle popolazioni slave. Un ricordo autentico e non mistificato di quella fase storica, che precede immediatamente “foibe ed esodo” non può che partire, naturalmente senza giustificazionismi né tentativi di minimizzazione, da questi dati oggettivi. I quali non rappresentano un semplice antefatto di quanto si rievoca con il giorno del ricordo, ma fanno parte di un’ unica storia e debbono rientrare in una visione complessiva. Una visione che oggi, 10 febbraio, i media, tranne qualche eccezione, oscureranno, impegnati – segnali ben precisi si sono già avuti nei giorni scorsi- nella propagazione di quella che è divenuta ormai verità di Stato, largamente egemonizzata dalla narrazione della destra nostalgica e revanscista, fatta di vittimismo autoassolutorio o addirittura autocelebrativo, sciovinismo antislavo e, qua e là, di larvata rivalutazione del fascismo. Facendo così compiere uno spaventoso passo indietro non solo alla comprensione del nostro passato, ma anche alla consapevolezza necessaria per affrontare adeguatamente il presente.
Luigi Caputo
Federazione PRC Avellino



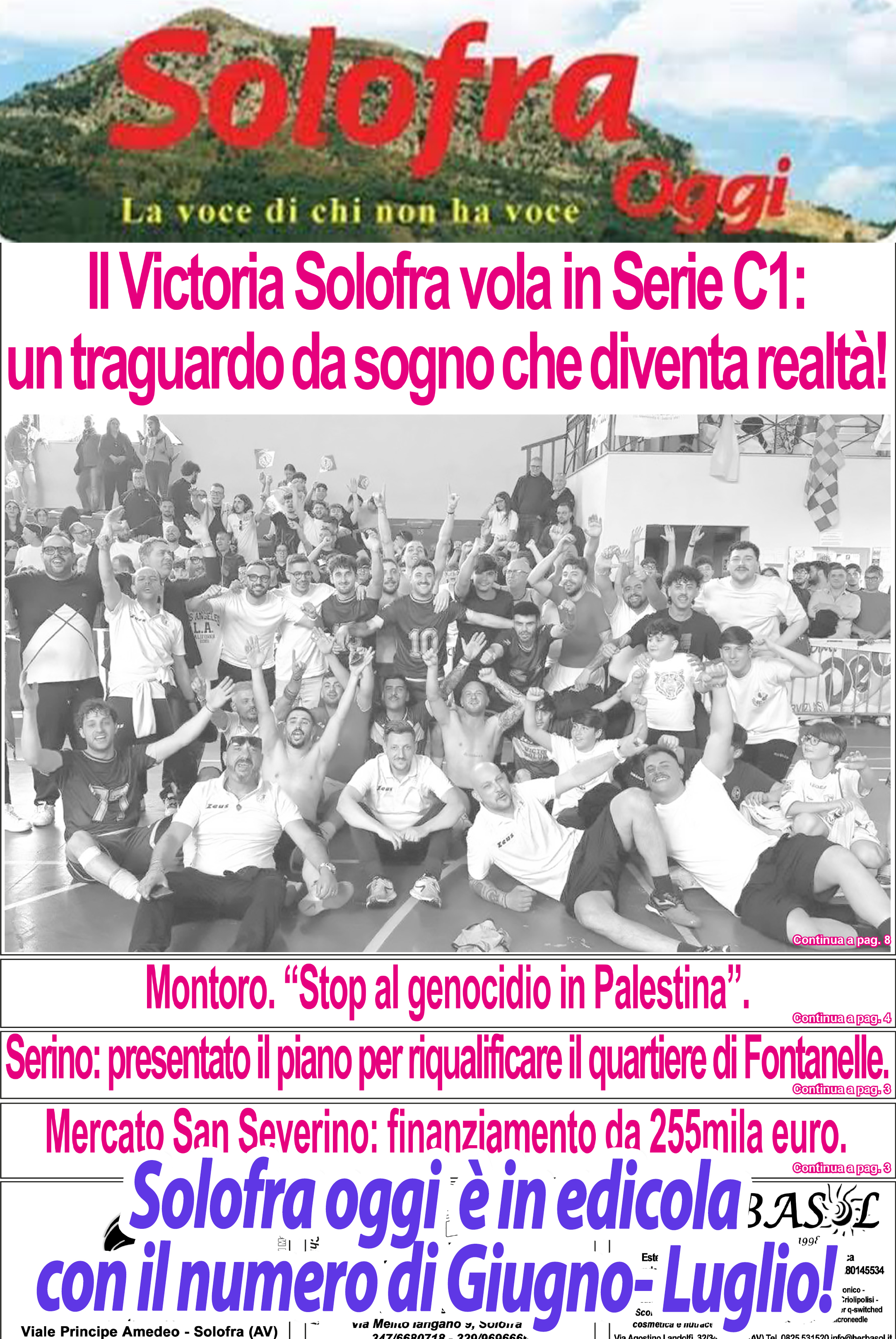
.jpg)

.jpg)
12.jpg)
1.jpg)
.jpg)