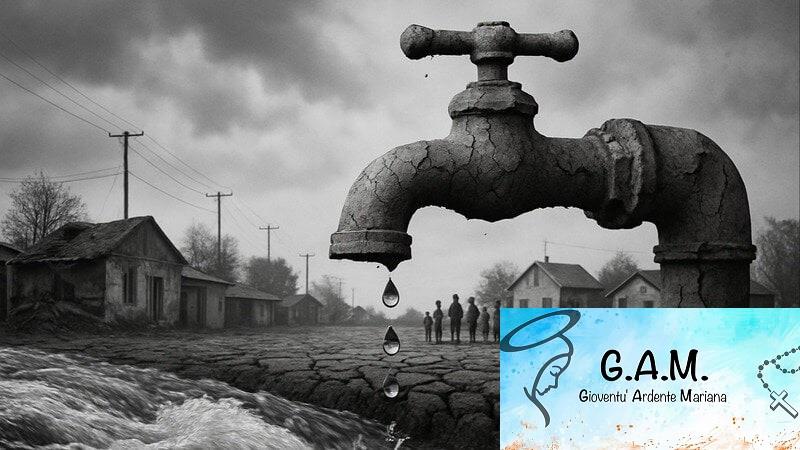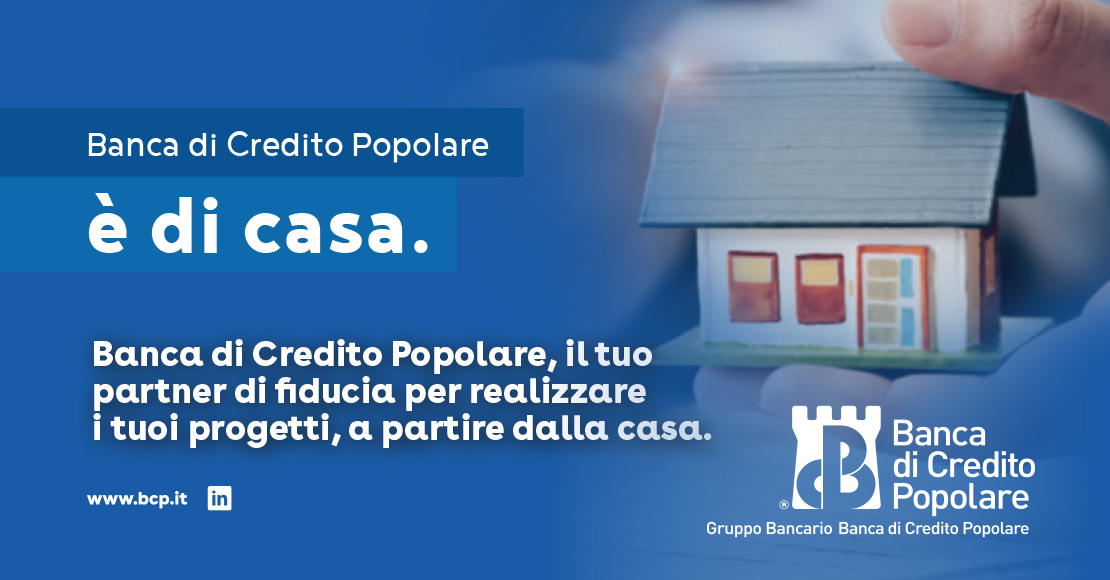Una testimonianza per la storia
La testimonianza, resa oggi dal Presidente Napolitano al Quirinale, rappresenta un fatto assolutamente nuovo per il Paese.
Infatti, per la prima volta, un Capo di Stato in carica ha dovuto rispondere alle domande dei giudici nel corso dell’udienza di un processo, che nasce da un’impalcatura accusatoria molto articolata e problematica.
La trattativa Stato-mafia, che sarebbe avvenuta nel biennio 1992-1994, inerisce ad una pagina della nostra storia, che molto probabilmente non potrà essere approfondita adeguatamente solo nel corso di un procedimento penale, che – nella migliore delle ipotesi – giungerà alla definizione di una verità giudiziaria, che costituirà parte esigua della ben più complessa ed ampia verità storica.
Molte cose sono state scritte e dette intorno a tale tematica; peraltro, nel corso delle ultime settimane, l’attenzione dei media si è soffermata, in modo particolare, su aspetti inquietanti, che ovviamente necessitano di un approfondimento, che ci aiuti ad andare oltre la pagina seducente di un articolo ovvero l’efficacia comunicativa di una pellicola cinematografica.
Certo è che, molto spesso, la storia italiana si intreccia con vicende di natura processuale: ad esempio, l’atto inquisitorio contro il Presidente Giulio Andreotti, accusato dalla Procura di Palermo di associazione a delinquere di stampo mafioso, fu – per eterogenesi dei fini – il processo contro la Prima Repubblica e la classe dirigente, democristiana e socialista, che ebbe responsabilità di Governo, in Italia, prima del 1994.
Orbene, in tal caso, la mera testimonianza del Capo dello Stato, pur non configurandosi alcuna accusa nei suoi confronti, può tornare utile per scopi unicamente strumentali, volti a gettare fango su di lui e su talune personalità, che hanno occupato posizioni di potere negli anni della Seconda Repubblica.
È, questo, il dramma di una nazione che non è stata mai capace di realizzare un cambiamento radicale delle istituzioni e delle proprie classi dirigenti, prescindendo dalle Aule dei Tribunali e dalle incriminazioni delle Procure della Repubblica disseminate per l’intera penisola.
È ovvio che, a distanza di venti anni dalla presunta trattativa, quei fatti – per quanto indefiniti e, tuttora, nebulosi – tornano drammaticamente utili per delegittimare chi, ancora, è ai vertici dello Stato democratico e, dunque, per favorire un rinnovamento, che non nasce "iuxta propria principia".
Sarebbe - allora - opportuno arrivare, finalmente, ad una piena maturità civica, che non sempre ha segnato la storia italiana, tanto più nei momenti di transizione, come quello che stiamo or ora vivendo.
Ciò appare viepiù giusto ed auspicabile in una contingenza nella quale le istituzioni rappresentative hanno bisogno di riferimenti saldi, che siano di guida – sul piano essenziale della moralità – per la pubblica opinione e per quei giovani - forse, inesperti - che si vanno ad affermare nei partiti ed all’interno delle organizzazioni sociali intermedie.
Solo procedendo per vie endogene ed in forma indipendente da dinamiche extra-politiche, si potrà finalmente arrivare ad un virtuoso rinnovamento della democrazia, così da poter garantire le condizioni necessarie per rinsaldare il rapporto fra lo Stato e la nazione, tanto più in una fase triste di smarrimento morale e di crisi economico-finanziaria, come quella odierna.
Rosario Pesce



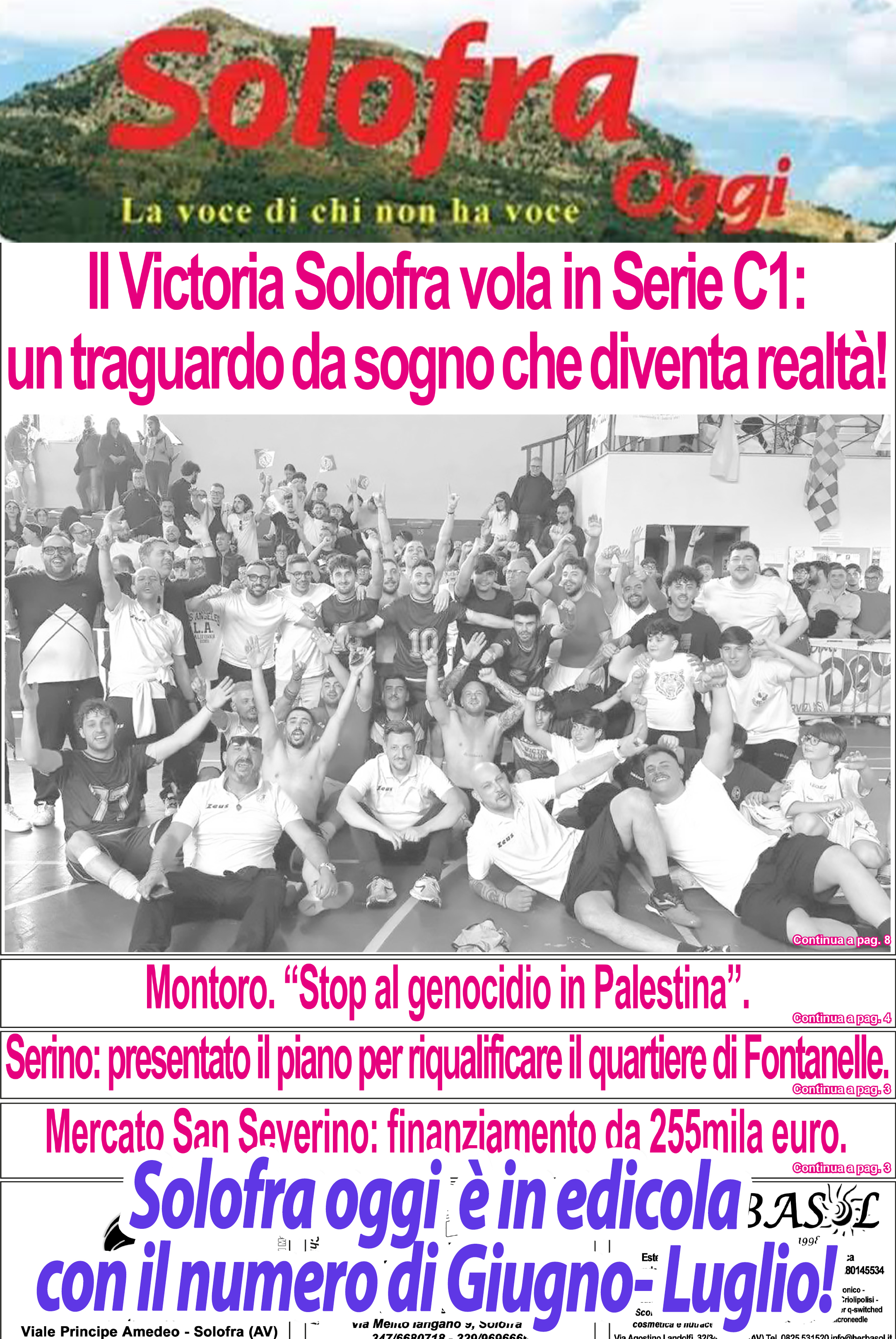
.jpg)