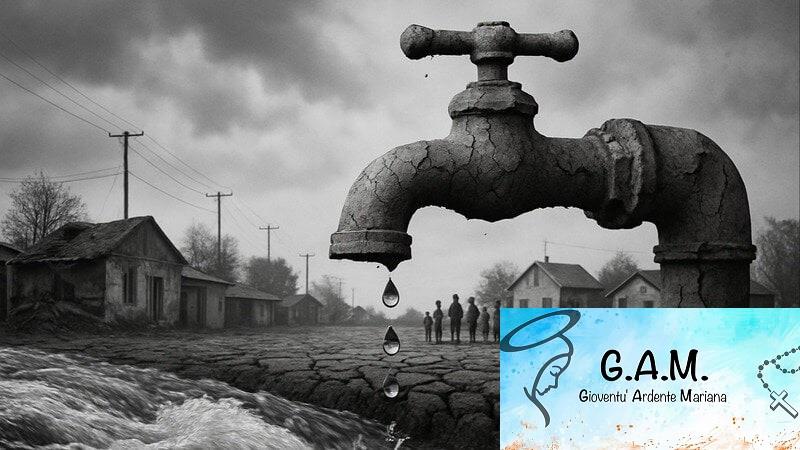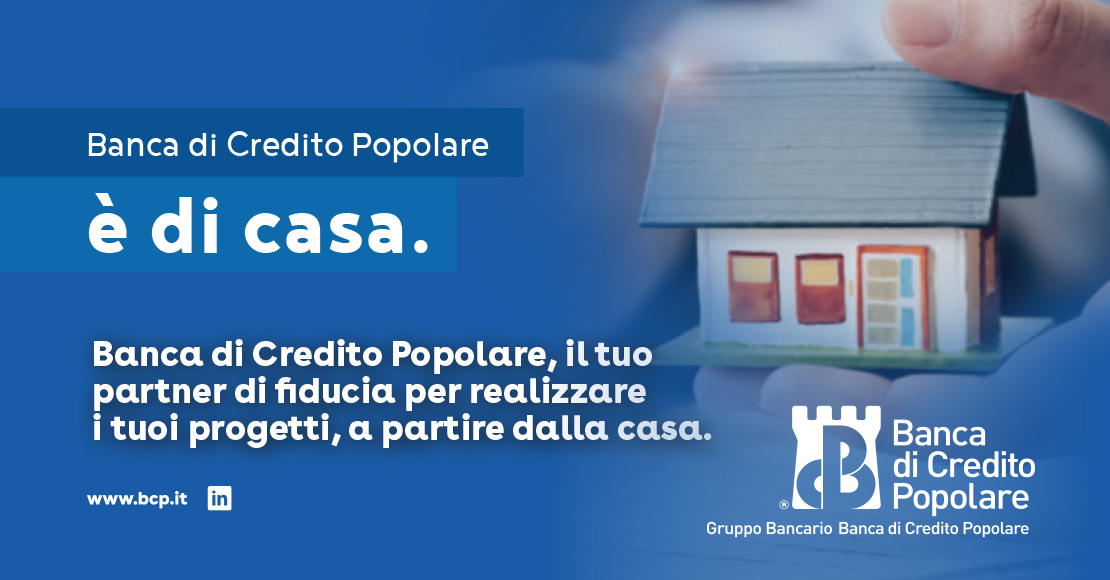La Chiesa e la povertà del nuovo secolo
La crisi economico-finanziaria, che sta interessando il mondo occidentale dal 2007, certamente non lo riguarderà solo per un breve periodo di tempo, ma, dal momento che si prospetta sempre più come elemento strutturale, definirà gli equilibri sociali per i prossimi decenni: infatti, la fase espansiva dell’Occidente si è conclusa al volgere del secolo scorso e del secondo millennio, mentre ora si prospetta una lunghissima fase che, invero, cambierà gli usi ed i costumi delle persone, che riusciranno a sopravvivere alla diminuzione delle ricchezze ed alla contrazione vistosa dei consumi.
Non è la prima volta che, nella storia dell’Occidente, si registra una crisi di tale portata, ma quelle precedenti avevano, tutte, una natura congiunturale, per cui dal Mille in poi carestie, pesti, momenti tragici di interi consessi sociali avevano - comunque - un lieto fine, visto che, prima o poi, il processo produttivo si rimetteva in moto e, quindi, terminava finalmente la congiuntura negativa.
Ora, invece, ci troviamo in una condizione ben diversa: è evidente che il mondo non ha le risorse necessarie per garantire il benessere a circa sei miliardi di individui, che affollano il pianeta, per cui, a meno che non si immagini una riduzione demografica drastica per effetto del consumarsi di eventi luttuosi, è chiaro che si va incontro ad una decrescita ed il continente più colpito è l’Europa, perché è quello che, nel corso del Novecento, ha goduto degli standard di ricchezza più alti, per cui la differenza fra la condizione odierna e quella passata è tanto più marcata ed impattante per chi non era abituato a vedere delle scene di povertà simili a quelle che i nostri nonni e padri hanno conosciuto negli anni del Secondo Conflitto Mondiale ed, immediatamente, dopo.
La decrescita non è mai felice, perché nessun essere umano può rinunciare ad una parte – più o meno rilevante di sostanze – facendo salti di gioia: la rinuncia, infatti, a quote considerevoli di benessere fa intendere che i figli avranno sempre meno dei loro genitori e, pertanto, il pensiero sul domani è, invero, molto più inquietante di quello sull’oggi, dal momento che ciascuno di noi è, almeno teoricamente, disposto a fare dei sacrifici, ma soffre quando immagina che la propria prole non possa godere del medesimo benessere, che le generazioni precedenti hanno avuto.
Pertanto, la riflessione sulla crisi nasce, fondamentalmente, da un’idea negativa sul nostro futuro e su quello dei discendenti, dal momento che siamo appena all’inizio di una fase di decrescita, che in parte ci riserva, tuttora, il godimento delle ricchezze residuali del periodo precedente.
Fra venti anni, ci troveremo nel bel mezzo della crisi ed, allora, le nostre coordinate, morali e temporali, cambieranno effettivamente: ad esempio, ci ha sorpresi non poco la proposta avanzata dal Governo di mettere in busta paga il Tfr, a testimonianza del fatto che il principale e più preoccupante effetto della povertà odierna è la cancellazione dell’idea stessa di futuro; prendere oggi ciò che - altrimenti - si sarebbe risparmiato, per entrarne in possesso domani, fa intendere che l’umanità non vede più una prospettiva felice per l’esistenza sua e delle generazioni prossime, ma ormai, per effetto della povertà incipiente, vive entro l’orizzonte più ristretto del godimento immediato di ciò che non può rinviare ad un futuro prossimo, che le sembra sempre più lontano e, soprattutto, dai tratti oscuri.
La povertà, dunque, modifica profondamente le nostre categorie morali: la categoria dell’hic et nunc prende il posto dell'idea di progresso, che ormai sembra solo un feticcio della filosofia dell’Ottocento, quando l’uomo nutriva, ancora, la speranza che il mondo potesse crescere all’infinito, perché esso era concepito come espressione dello svolgimento di uno Spirito, che dava senso alle cose mondane, in vista del raggiungimento di un obiettivo creato in funzione di un fine trascendentale.
Oggi, questo margine non esiste più e, soprattutto, viene meno progressivamente il ruolo dello Stato, codificato - appunto - dai pensatori e filosofi del XIX secolo; infatti, la Res Publica si ritrae sempre più e l’agone sociale è occupato, in modo prepotente, da interessi di parte, meramente di natura privatistica, per cui il confronto economico e sociale non è più tra pubblico e privato, ma tra un privato, ancora sano, ed un privato che, a volte, nasconde interessi non legittimi e contrari, manifestamente, all’interesse comunitario.
In particolare, lo Stato, per effetto della mancanza di liquidità, ma anche per una ben precisa volontà politica, si sta ritraendo dai Servizi Sociali, dall’Istruzione, dalla Sanità, lasciando il posto a famelici investitori privati, che intendono fare della crisi l’occasione utile per il perseguimento di finalità non sempre compatibili con il Bene pubblico; in tale dimensione, diventa essenziale il ruolo di quel cosiddetto “privato sociale”, che, nelle nostre aree, può essere adeguatamente rappresentato, solo, dalla Chiesa.
Infatti, quale istituzione può assolvere ad un ruolo, genuinamente, caritatevole se non la struttura religiosa, che, in tale settore, ha accumulato un’esperienza di due millenni circa?
In particolare, la Chiesa cattolica ha attraversato la storia di tutto l’Occidente, a partire dalla crisi dell’Impero Romano sino ad oggi, essendo un punto di riferimento per quanti l’hanno osannata, come per coloro che – a torto o a ragione – l’hanno, aspramente, criticata.
Orbene, oggi il suo ruolo diventa di nuovo centrale, anche in quelle società - come la nostra - fortemente laicizzate: infatti, l’arretramento dello Stato lascia libero uno spazio enorme, che pure dovrà essere occupato da altre nobili istituzioni, in grado di assolvere al ruolo che, invece, viene abbandonato dall’entità statuale; diventa, a questo punto, finanche improbo parlare di distinzioni fra l’ambito confessionale e quello laico, perché, nella misura in cui la Chiesa è in grado di assicurare ciò che lo Stato non può più offrire in termini di assistenza ai nuovi poveri, sempre più numerosi e drammaticamente privi dell’essenziale, è ovvio che discorrere di laicità diventa un lusso, che l’Occidente del XXI secolo non può più permettersi.
In tal senso, l’operazione di rilancio dell’immagine dell’istituzione, creata da Pietro, svolta negli ultimi due anni da Papa Bergoglio, non solo è utile, ma diventa provvidenziale, perché evita che la Chiesa possa essere “rottamata” – rischio, questo, per nulla irrilevante, vista la decadenza dei costumi registrata, al suo interno, negli ultimi decenni – ed, anzi, le garantisce un futuro aureo, paragonabile al passato importante, che essa ha avuto nel corso del Medioevo e della prima parte dell’età moderna.
Ormai, parlare di democrazia e libertà implica - molto più che in passato - promuovere una riflessione autentica sul ruolo dell’organismo ecclesiastico nella nostra società, perché il disprezzo fortissimo, che ricade sulla classe dirigente italiana degli ultimi trent’anni, fa sì che, a maggior ragione, il cittadino comune guardi alla Chiesa come ultima àncora di salvataggio, cui aggrapparsi non solo per soddisfare bisogni primari, ma anche per trovare un conforto morale alle sofferenze quotidiane.
Forse, la filosofia della politica dovrà tornare alle categorie della teologia per meglio spiegare il presente?
Forse, le nostre riflessioni hanno uno sfondo meramente sociologico, che dovrà ulteriormente arricchirsi da un punto di vista strettamente teoretico?
Forse, l’Occidente - come l’Ebraismo - è in attesa di un nuovo Messia, che possa fargli recuperare le speranze disattese dall’Uomo moderno?
Rosario Pesce



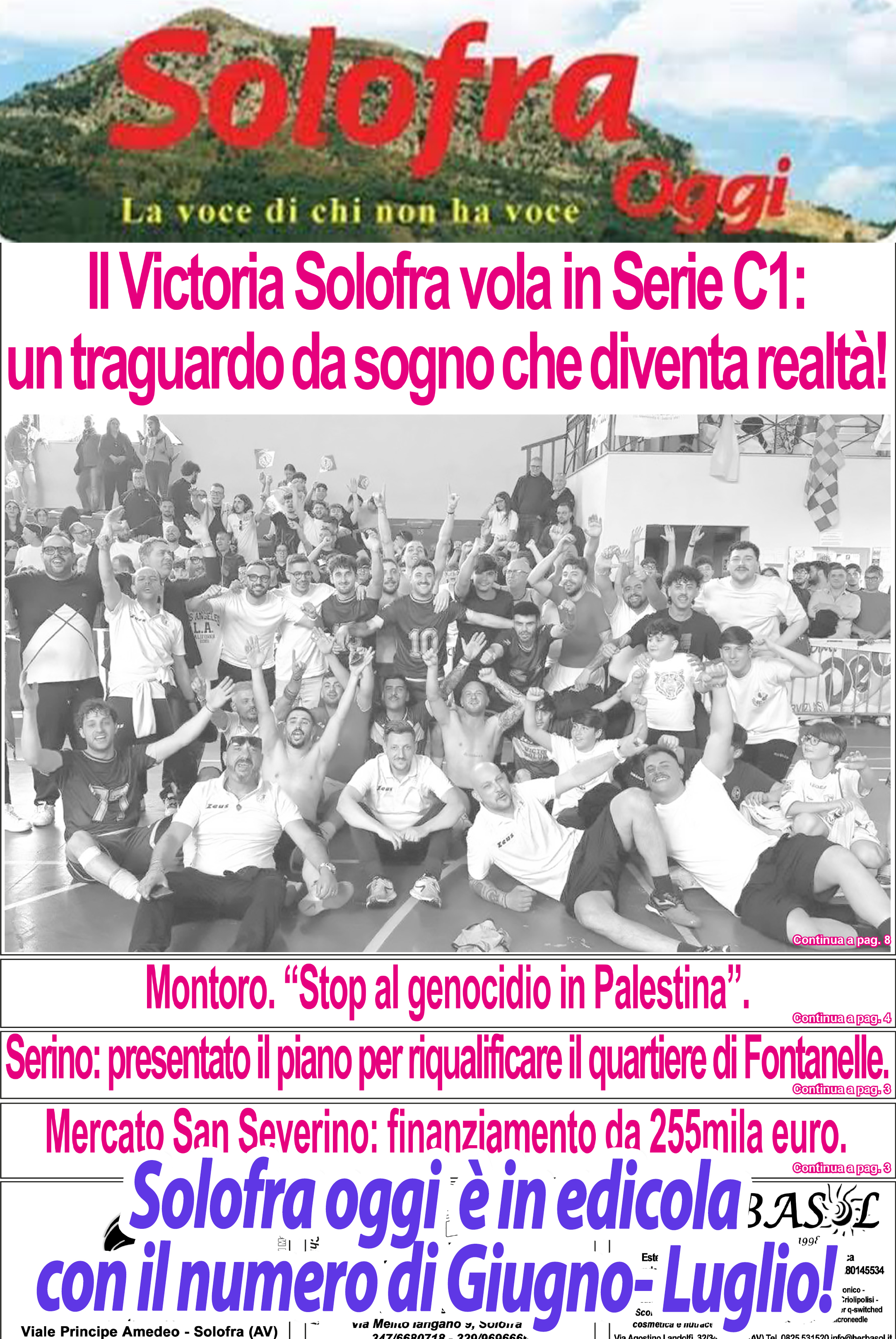
.jpg)