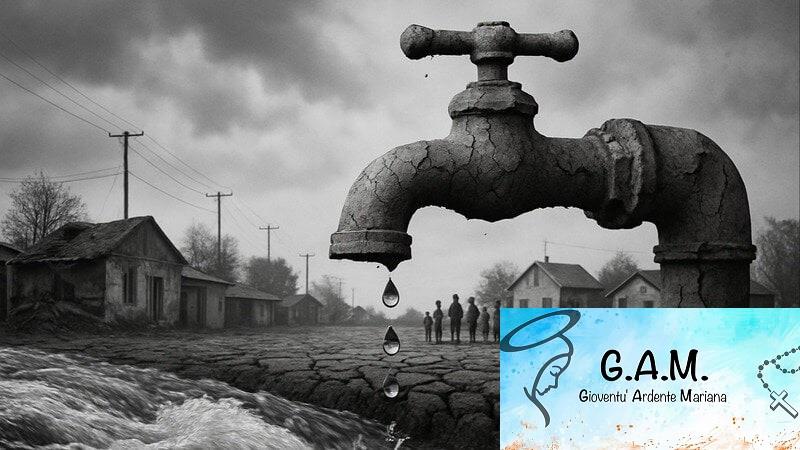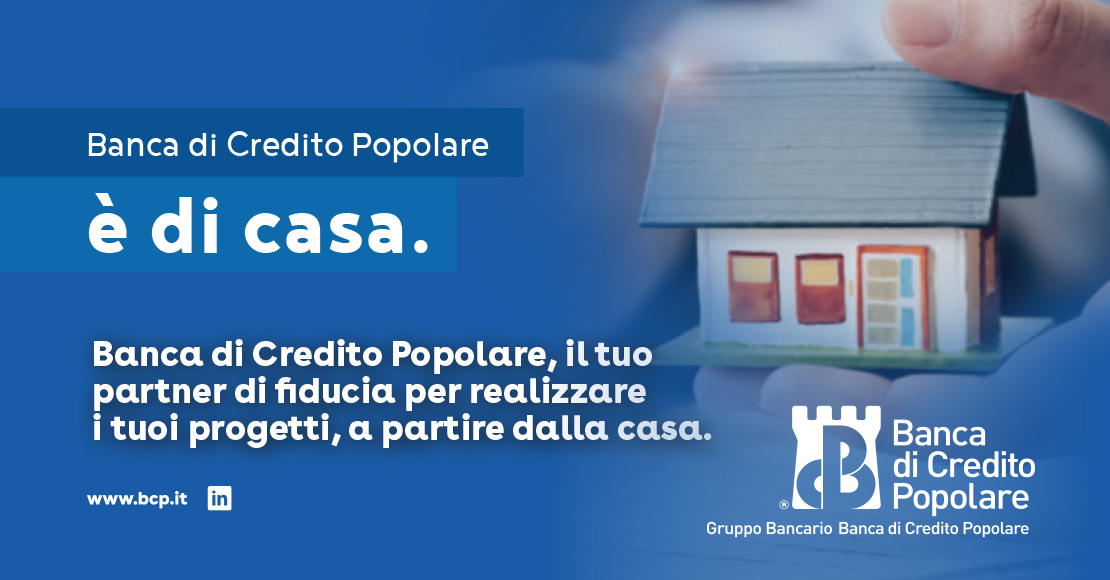Presente e passato
Una bella intervista di Eugenio Scalfari al giornale da lui fondato, La Repubblica, costituisce occasione utile per una riflessione sul presente ed il passato quali dimensioni dell’agire individuale e collettivo di una società.
Appare evidente al grande giornalista che l’Italia odierna, ma forse anche il vecchio continente, sia ignara del proprio passato, come se fosse vivo un anelito generalizzato a progredire, dimenticando però i grandi esempi ed i punti di riferimento ideali - finanche quelli più gloriosi - che non andrebbero mai rimossi.
In politica, ad esempio, questa tendenza, dominante da tempo, è ben espressa dalla volontà di rottamare interi gruppi dirigenti, i quali vengono avvertiti come un peso per la democrazia: il rischio, naturalmente, in questo caso, è che si getti – come si dice in gergo – “con l’acqua sporca, anche, il bambino”.
Gli adolescenti odierni ignorano quasi del tutto la storia italiana, per cui il loro sguardo temporale è limitato all’immediato presente: diventa operazione complessa farli ragionare su fatti e personaggi degli anni Cinquanta o Settanta del secolo scorso, come se prevalesse un istinto iclonocasta, che porta a distruggere ed a rimuovere ogni immagine risalente al passato, sia esso prossimo o remoto.
Tale istinto si potrebbe immaginare teso alla palingenesi, cioè ad una ridefinizione della nostra natura, ma sappiamo bene che, ogni qual volta l’uomo abbia tentato di rinascere, ha ricominciato sempre dal dato già costituito, cioè è ripartito da ciò che esso era precedentemente, mentre annullare tout court il passato significa semplicemente cancellare - con un colpo di spugna - ciò che si è stati, nel bene e nel male.
Una rinascita, che non sia cosciente di se stessa, cioè che non abbia inizio da ciò che siamo stati o siamo tuttora, è inevitabilmente destinata al fallimento, perché non esistono né individuo, né società che possano costruirsi, in modo programmatico, sul nulla.
Eppure, l’uomo del XXI secolo risponde al modello dell’essere umano privo di memoria, sia di quella storica, sia di quella privata, che neanche più le scuole o i grandi Maestri contribuiscono a tenere viva, per cui sogni, desideri, aneliti, pulsioni, che non siano solo istintuali, sembrano non avere più diritto ad albergare nella vita quotidiana.
In politica e nelle istituzioni, poi questa tendenza è accentuata dal meccanismo del consenso, che premia costantemente coloro che aspirano a rompere con il passato, anche se poi non sono capaci di delineare un modello alternativo a quello che vogliono distruggere, come se la pulsione della distruzione sia, sommamente, prevalente e possa prescindere dall’istinto creativo.
In passato, l’umanità ha vissuto momenti fortemente contrassegnati da uno spirito di rottura con il dato precedente, ma quelle contingenze rivoluzionarie – sia nel campo delle idee, che della politica e della vita statuale – erano accompagnate da un modello ideale, che si intendeva costruire, per cui la “pars destruens” era seguita sempre da una “pars costruens”, a volte concepita in modo molto rigoroso ed a seguito di studi ed analisi assai forbiti.
Ora, invece, prevale il desiderio di distruzione meramente finalizzato a se stesso, come se distruggere, rompere stereotipi – ormai, consolidati – possa racchiudere in sé e soddisfare pienamente ogni sforzo umano di trasformazione del reale.
A volte, mi torna in mente la sequenza iniziale di “2001 - Odissea nello spazio”: l’uomo pare essersi fermato a quello stadio, ben descritto dalle immagini che narrano l’assenza di cultura e la mancanza di autocoscienza del nostro primate, impegnato a distruggere - finanche - gli elementi minimi di creatività naturale.
Forse, duemila anni dopo la nascita di Cristo, al volgere di secolo e di millennio, l’umanità è caduta in un sonno della ragione, ben più pericoloso e profondo di quello che, in secoli precedenti della nostra storia recente, ha generato mostri inenarrabili, come guerre, devastazioni di massa e stermini di interi popoli?
Forse, la dimensione consumistica ha ridotto l’essere umano allo stadio di divoratore insano del proprio “sé” e della coscienza sociale costruita da millenni di storia nobile e degna, comunque, di essere menzionata?
Forse, è solo un incubo, da cui presto ci risveglieremo?
Rosario Pesce



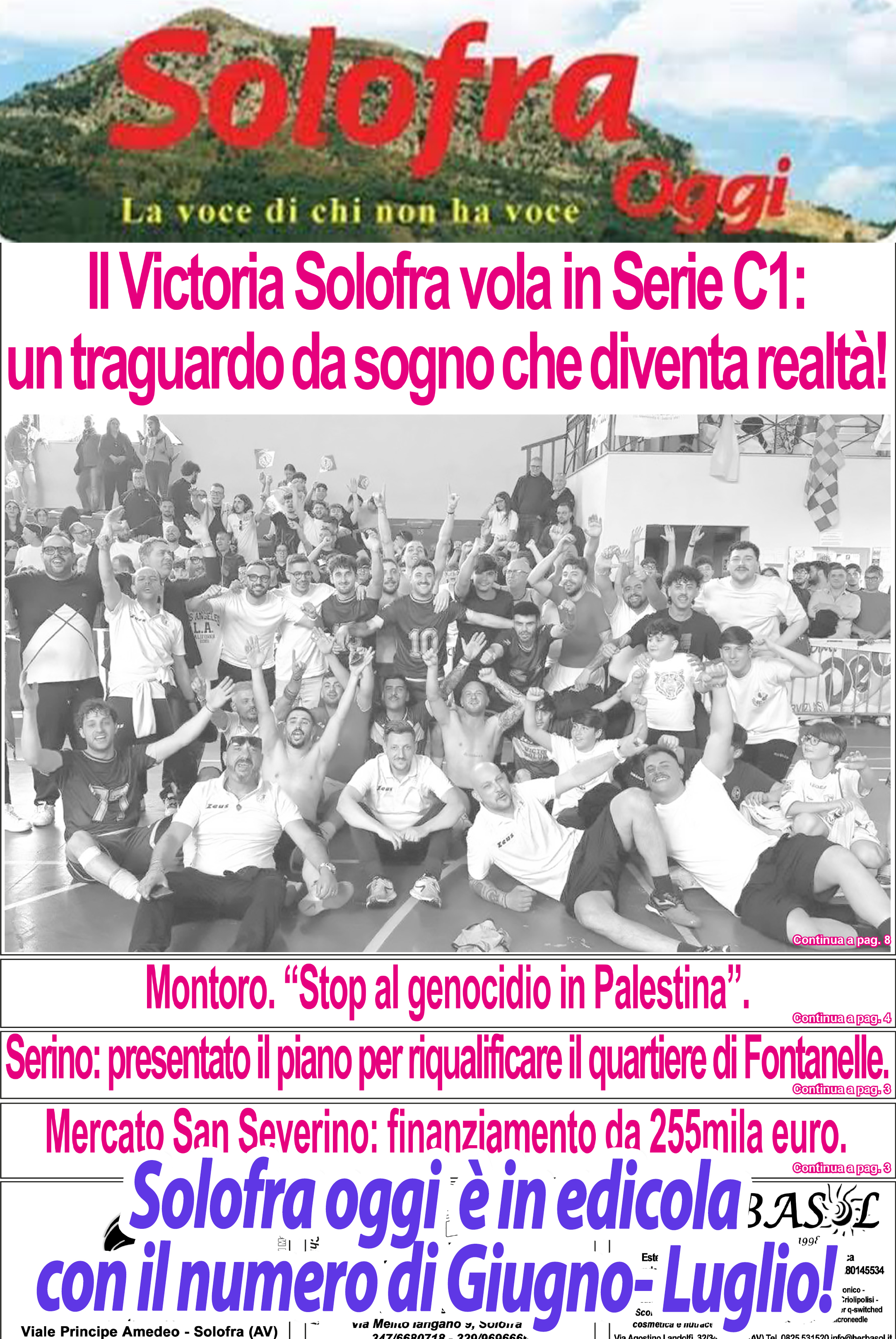
.jpg)