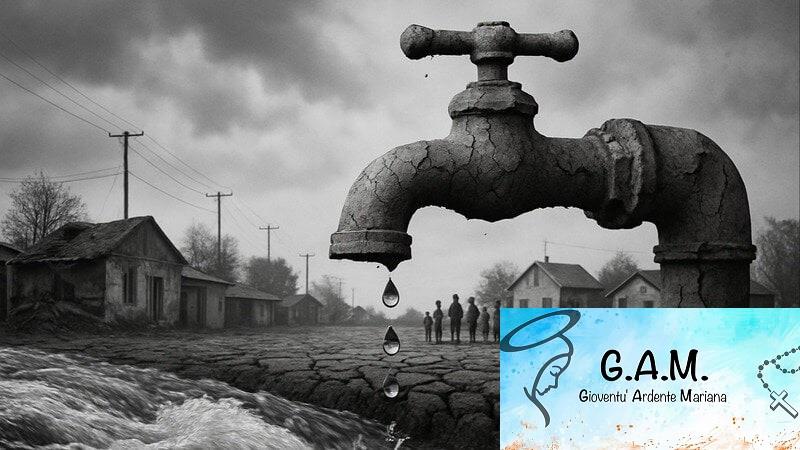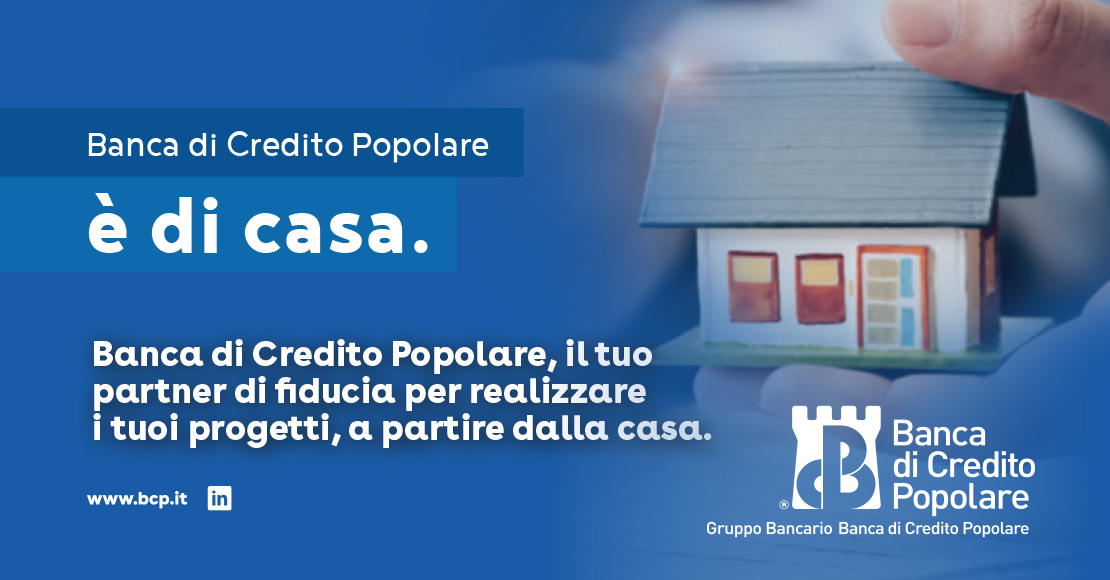Quando il degrado del Sud non basta per spiegare…
Le cause dell’episodio increscioso, verificatosi a Napoli nel corso della primissima mattinata di venerdì, che ha visto l’uccisione di un adolescente da parte di un agente - che ha colpevolmente sparato contro il motorino, su cui viaggiavano la vittima e due suoi compagni con precedenti penali - non possono essere descritte, solamente, ricorrendo al degrado delle periferie urbane o alla vita criminale, che purtroppo dilaga nella città partenopea, così come in molte altre metropoli sia del Sud, che del Nord.
È ovvio che, in un episodio siffatto, le vittime siano molteplici: innanzitutto, il ragazzo minorenne ed incensurato che ha perso la vita, il quale ha l’unica colpa di essersi trovato, alle tre del mattino, a bordo di uno scooter con amici, che avevano precedenti con la Giustizia e che, dunque, non potevano fermarsi al posto di blocco, dove era stato intimato loro l’alt; l’altra vittima è l’agente che avrebbe sparato ad altezza d’uomo, colpendo a morte il povero adolescente: egli sarà indagato per omicidio colposo e, certamente, sarà sospeso dal servizio, in attesa che possa discolparsi da un’accusa così grave.
Ma, vittime sono, anche, gli altri due adolescenti, di cui uno era fuggito dagli arresti domiciliari, a dimostrazione che esistono ampi strati della popolazione giovanile, che vivono in una condizione di illegalità e disagio diffusi, per cui c’è chi, momentaneamente agli arresti presso il proprio domicilio, giunge a realizzare un’evasione per uscire di casa nel cuore della notte, all’unico scopo di trascorrere qualche ora in compagnia di coetanei, per bighellonare in un quartiere, invaso a quell’ora, da spacciatori e criminalità organizzata.
Un tempo, si sarebbe detto che l’episodio funesto dell’altro giorno è frutto dell’emarginazione, che si vive in determinate aree del Paese, dove il controllo della legalità è così difficile, che interi territori sono nelle mani di bande di giovani criminali, che mettono a repentaglio la loro stessa esistenza per mettere in piedi piccoli crimini, che - comunque - non potranno mai assicurare loro un’esistenza dignitosa e civile.
Certo è che la condizione dei tre giovani napoletani non è molto dissimile da quella dei loro coetanei, che vivono in altri tessuti urbani più sani di quello della città partenopea, infestato dalla presenza capillare delle famiglie della camorra.
Esiste, infatti, in Italia un’emergenza giovanile, davvero, assai preoccupante, se si pensa che una parte rilevante dei nostri adolescenti non è impegnata in percorsi di formazione/istruzione, né svolge una normale attività lavorativa dopo il compimento ordinario dell’obbligo scolastico.
Ormai, se prima si poteva parlare di questione meridionale, oggi, molto più correttamente, si deve parlare tout court di “questione adolescenziale”, visto che gli adolescenti costituiscono, insieme agli anziani, l’anello più debole della società odierna, che abbiamo costruito nel corso degli ultimi venti anni: essi non hanno futuro professionale; solo raramente hanno un livello di istruzione, che può metterli nelle condizioni di competere con i coetanei europei e, soprattutto, non hanno alcun riferimento istituzionale a cui relazionarsi.
Infatti, quando la famiglia viene meno, rimane come loro unica compagna di vita la strada, dove – come nel caso sopra descritto – la persona sana può venire in contatto, facilmente, con amici che hanno ben altra fedina penale e, dunque, corre il rischio di rimanere coinvolta nelle loro bravate, che comportano costi a volte altissimi, fino alla perdita della vita.
È evidente che invocare delle politiche di sostegno all’adolescenza ha scarso senso, dato che, negli anni passati, lo Stato italiano ha speso cifre ingenti per venire incontro a simili forme di devianze, senza peraltro ottenere grandi risultati.
Si invoca, da più parti, il ruolo della Scuola, quello della Chiesa o di tutti gli altri corpi sociali intermedi, che dovrebbero dimostrarsi preziosi nel combattere qualsiasi forma di dispersione, ma è lapalissiano che, quando queste istituzioni comunicano poco fra loro o non hanno le risorse - umane ed economiche - necessarie per svolgere il compito loro affidato, diventa davvero difficile, finanche, tentare di salvare migliaia di giovani, altrimenti condannati ad una vita fatta di emarginazione, illegalità ed abbandono.
Forse, bisognerebbe usare diversamente i fondi europei, allo scopo di creare occasioni effettive di lavoro e di crescita per ragazzi che, una volta raggiunta la maggiore età, rischiano di trascorrere più ore della propria vita in carcere, che non in regime di libertà?
Forse, bisognerebbe rifondare il canone morale della società odierna, perché, quando l’Occidente ha gioito perché “Dio è morto”, ha creato le premesse per la costruzione del nostro infausto presente?
Forse, bisogna augurarsi che l’arrivo copioso sulle coste della penisola dei “nuovi” Italiani, nel corso del prossimo ventennio, possa creare le condizioni di quel cambiamento virtuoso, che la generazione nostra e quella dei nostri padri non sono state capaci di determinare?
In attesa che si possa dare una risposta convincente a siffatti quesiti, non ci resta, infine, che esprimere il profondo cordoglio per la perdita di una vita innocente, ben sapendo che, purtroppo, non sarà né l’ultima, né quella più traumatica.
Rosario Pesce



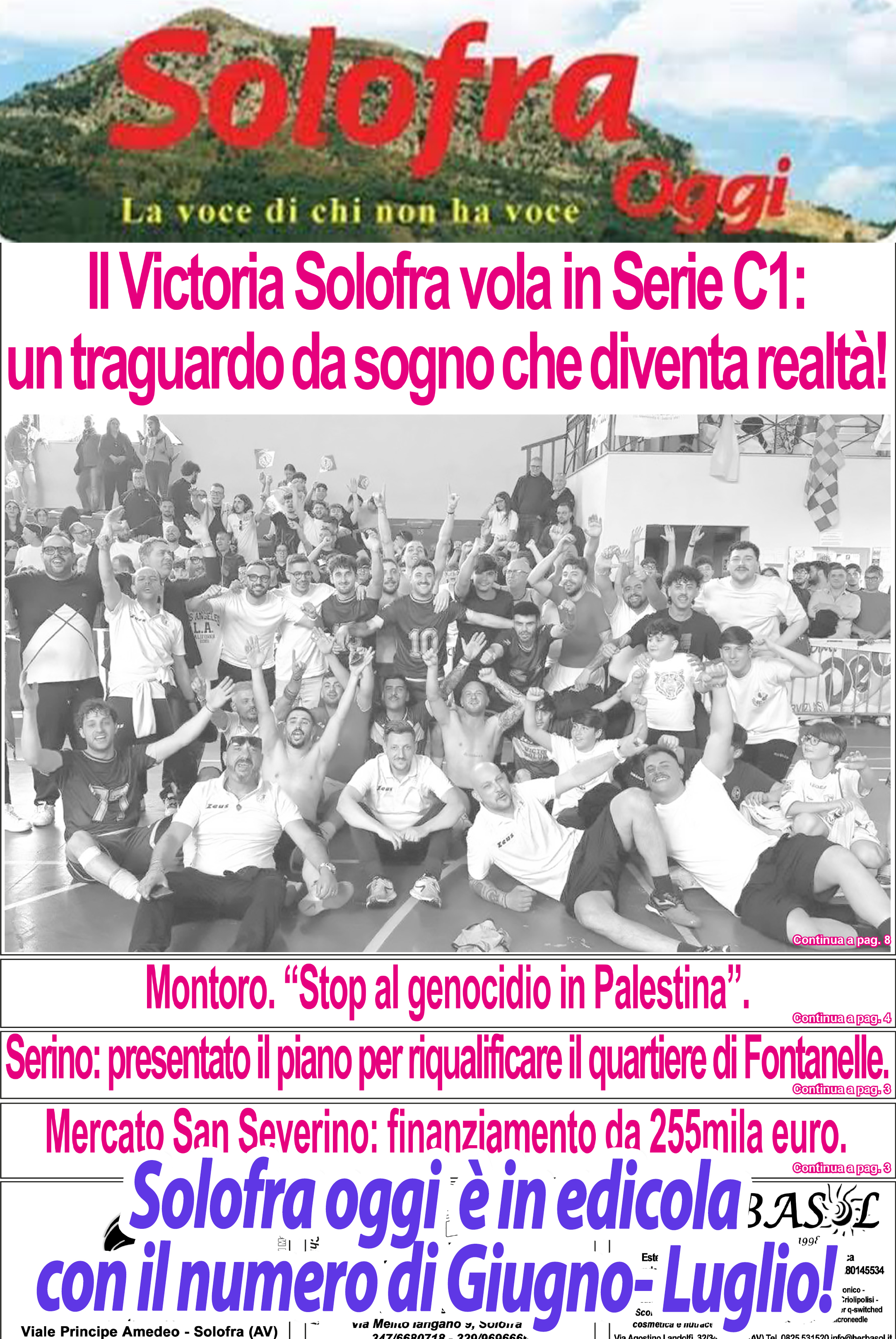
.jpg)