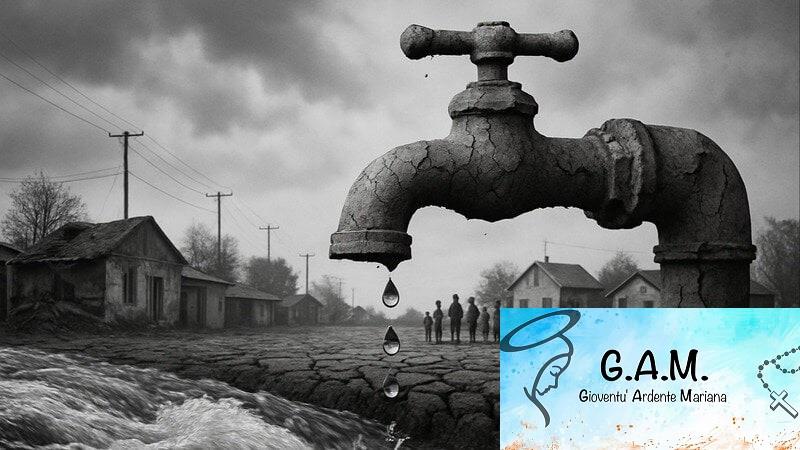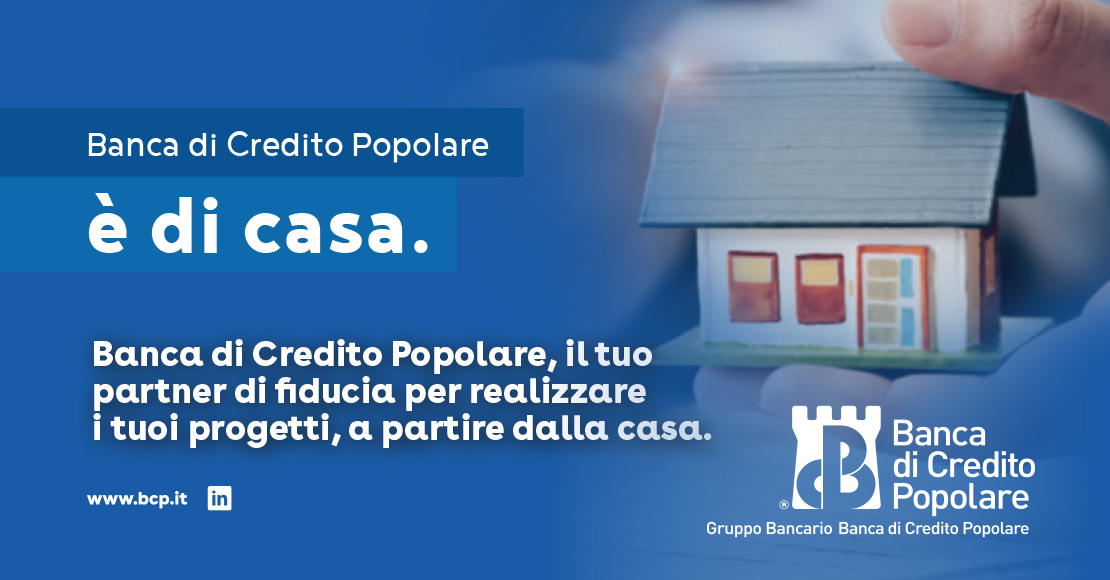venti di guerra
Si preannuncia un autunno problematico per chi aspira alla pace e al mantenimento dell’ordine internazionale con mezzi di natura non bellica.
Infatti, le posizioni di Russia ed Europa tendono ad essere sempre più divergenti in merito alla questione ucraina, visto che le sanzioni economiche, finora adottate nei confronti di Mosca, non solo non hanno comportato le conseguenze attese, ma hanno inasprito ulteriormente l’atteggiamento di Putin, il quale chiede quotidianamente alla comunità internazionale che venga riconosciuta la nascita di un nuovo Stato filo-russo, nato dalla disgregazione dell’Ucraina orientale, giungendo altrimenti a minacciare Kiev.
Se gli sarà impedito di coronare il desiderio di ampliamento del territorio nazionale russo, con la conquista dell’area già interessata dall’invasione delle sue truppe, egli ipotizza addirittura di entrare da invasore nella capitale ucraina, grazie allo strapotere delle forze militari in suo possesso, nettamente superiori agli strumenti difensivi, di cui possono avvalersi gli Ucraini.
In siffatti casi, i paragoni con la storia sono sempre inflazionati: c’è chi si è spinto a comparare Putin ad Hitler, per cui l’invasione odierna dell’Ucraina sarebbe, a distanza di più di settant’anni, il remake triste dell’occupazione della Polonia, avviata dalla Germania nazista il 1 settembre 1939.
Non vogliamo, anche, noi collocarci sullo stesso piano di riflessione, perché è sempre difficile analizzare condizioni storiche, che vantano alcuni elementi di similitudine, ma presentano - fortunatamente - moltissimi punti di differenza.
L’invasione polacca, ad opera delle truppe del Terzo Reich, segnò l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, che certamente è stato l’evento più triste, finora, della storia dell’umanità, visti i milioni di vittime civili, che essa ha determinato, e vista la conclusione che fu possibile, solo, in virtù dell’uso delle bombe atomiche sulle città del Giappone, ancora riottoso ad accettare la vittoria degli Alleati.
Oggi, crediamo di non essere alla vigilia dello scoppio della Terza Guerra Mondiale, perché il mondo non appare diviso nettamente in due fazioni, come lo era all’epoca di Hitler e Stalin.
L’Europa è, tendenzialmente, sulle posizioni della Germania, anche se con sfumature diverse: c’è chi, come i Paesi dell’Est, spinge per un intervento militare immediato in Ucraina, sperando così di causare il ritiro dei Russi dai territori che hanno occupato indebitamente, mentre c’è chi, come l’Italia, ha un atteggiamento molto più cauto, perché ritiene giusto tentare di convincere Putin al ritiro dei mezzi militari, solo, attraverso il ricorso a sanzioni di natura economica, che - però - hanno danneggiato molto più l’economia europea che non quella russa, che forse può ambire a tollerare il peso di diversi mesi, ancora, di sostanziale autarchia e di sospensione di tutti i traffici con i Paesi europei, con cui il saldo della sua bilancia commerciale è, nettamente, in attivo.
Evidentemente, gli interessi in gioco sono altissimi: l’Ucraina è una terra di fondamentale importanza negli equilibri geo-economici, dato che il gas, che alimenta le aziende e le case europee, viene in gran parte da quella terra, perché, estratto in territorio russo, deve transitare nelle regioni, appena, occupate da Putin, che dunque è spinto ad esercitare una piena sovranità - politica e militare - su quelle regioni, perché non intende riconoscere benefit, né vantaggi di altra natura agli Ucraini in merito alle vendite di gas che la Gazprom realizza sul mercato mondiale.
In assenza del rinvenimento di fonti energetiche alternative, è chiaro che Putin abbia una posizione di forza notevole rispetto al vecchio continente, perché è in grado di ricattarlo e di imporre, quindi, qualsiasi prezzo sul prodotto essenziale per il sistema industriale e la vita civile dell’Europa.
Peraltro, la crisi potrebbe aggravarsi, anche, per effetto della concomitante conflittualità nel mondo arabo; se, infatti, gli integralisti islamici dovessero conquistare per intero Siria ed Iraq - come è nelle potenzialità di questi ultimi - il petrolio ed il gas, che provengono dal Medio-Oriente, sarebbero gestiti interamente da loro, dato che quei Paesi sono i principali esportatori mediorientali dell’oro nero e visto che le altre due nazioni, che detengono petrolio in abbondanza - Arabia Saudita ed Emirati – avrebbero, allora, facile gioco ad alzare il prezzo, perché il loro petrolio rimarrebbe l’unica alternativa a quello in possesso degli integralisti islamici, che non a caso essi finanziano corposamente.
Quindi, l’incrocio di questi due teatri di guerra - quello orientale e quello asiatico - determinano condizioni di sofferenza in prospettiva, ancora, peggiori per l’Europa, dal momento che, se ci fosse un effettivo innalzamento del prezzo di gas e petrolio, l’economia europea, già disastrata, riceverebbe un colpo quasi mortale, perché l’innalzamento - che ne conseguirebbe - dei costi di produzione costringerebbe il sistema produttivo occidentale ad un regime di austerità, che abbiamo già conosciuto nel corso degli anni Settanta del secolo scorso.
Speriamo, pertanto, che la crisi delle ultime settimane possa trovare una soluzione diplomatica ragionevole per tutti i contendenti; altrimenti, ne nascerebbe una ferita non solo per gli equilibri politici internazionali, ma soprattutto per le future generazioni, costrette a vivere con minori margini di vivibilità ed, in particolare, di agio economico.
Rosario Pesce



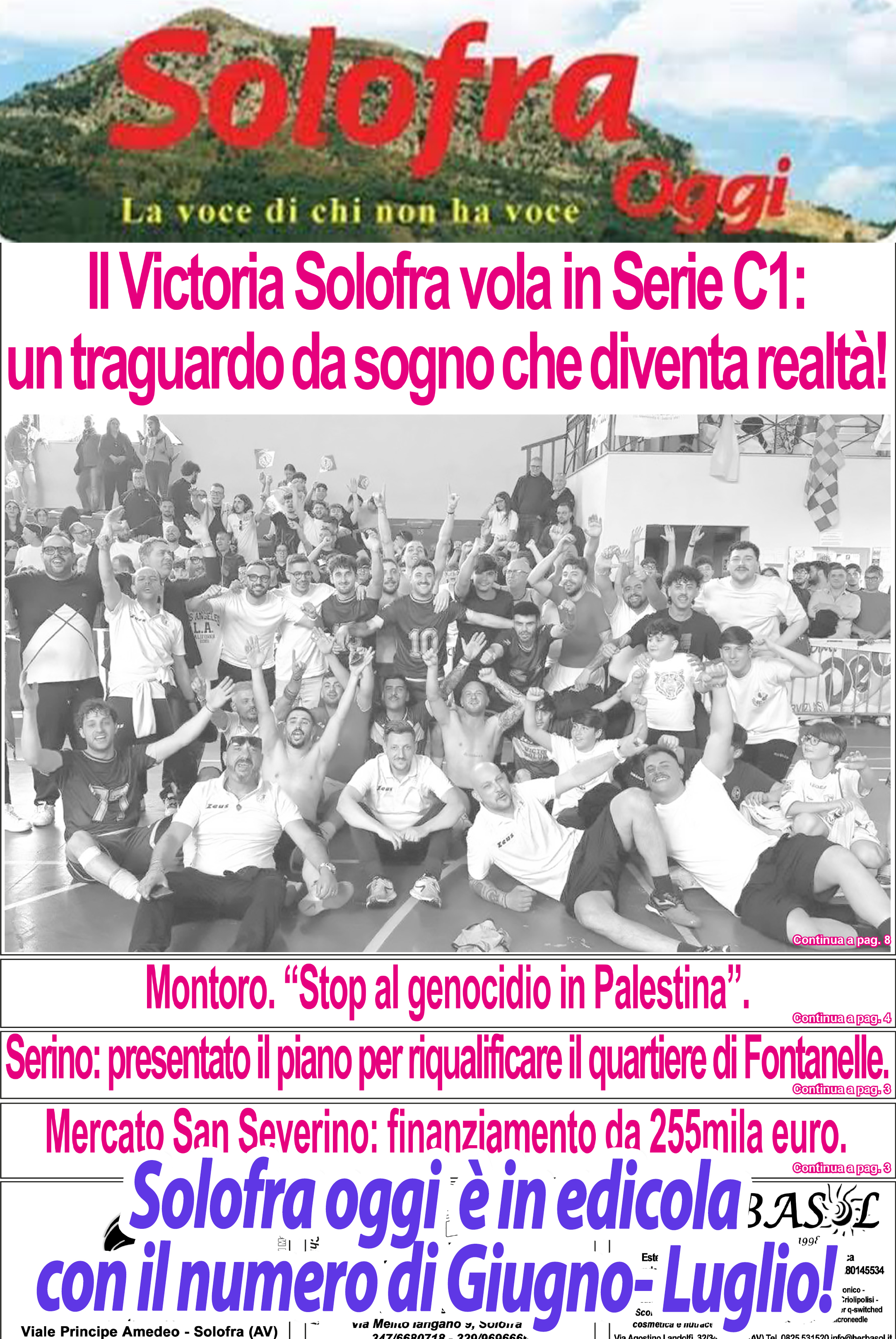
.jpg)