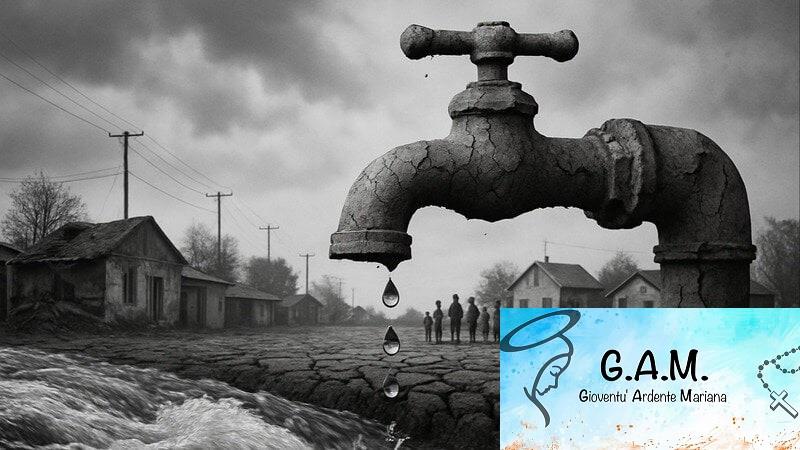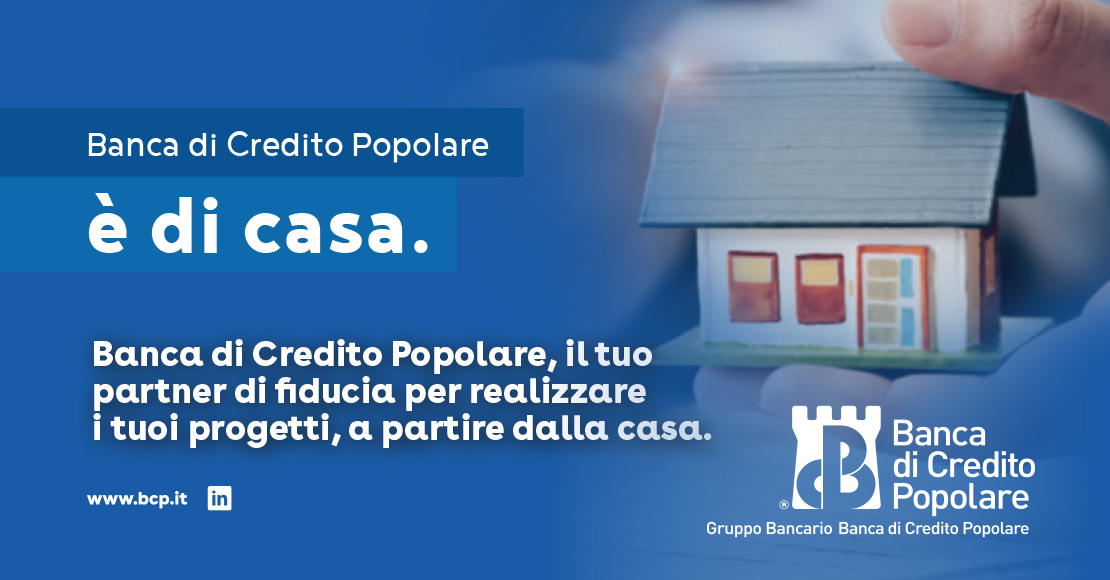Le élites e la politica
Uno dei temi fondamentali della scienza politica moderna è rappresentato dal rapporto fra le élites e la classe dirigente statuale di natura elettiva.
Infatti, il metodo democratico, sin da quando è stato introdotto, è stato uno strumento eccezionale attraverso cui l’élite di uno Stato si è ampliata, perché, molto spesso, gli eletti non erano, originariamente, appartenenti al ceto dirigente di quel Paese e lo sono divenuti, solo, a seguito dell’elezione.
Sappiamo bene come, a partire dalla conclusione del XIX secolo, quando in Europa si pose con maggiore insistenza l’esigenza dell’ampliamento della base sociale della classe governante, sorse il problema dell’individuazione dei criteri necessari per selezionare i nuovi governanti, che, integrandosi con le vecchie oligarchie già esistenti, avrebbero dovuto assicurare il cambiamento, anche se entro un quadro complessivo di conservazione e rafforzamento di aristocrazie dominanti, ormai, da secoli.
La lezione del Gattopardismo, soprattutto in Italia, è sempre stata validissima; infatti, come insegna Tomasi di Lampedusa, finanche un processo di straordinaria portata rivoluzionaria, come avrebbe dovuto essere il Risorgimento, si risolse molto più miseramente nella mera integrazione dei ceti dominanti con i nuovi accoliti, i quali venivano scelti, attraverso il metodo della cooptazione, da chi occupava una posizione di favore: metodo, questo, peraltro mai scomparso, visto che, tuttora, le invise baronie universitarie vengono a formarsi con il medesimo meccanismo, perché il notabile, che occupa una posizione di potere all’interno della gerarchia accademica, innova l’apparato burocratico, selezionando nuove e fresche energie, le quali si mettono a disposizione del rafforzamento e potenziamento di un notabilato già forte, senza intaccarne legittime prerogative ed aspirazioni ulteriori di potere.
La democrazia, per molti decenni ed ancora oggi, si atteggia purtroppo allo stesso modo: i segretari di partito, non a caso, hanno sempre manifestato il loro favore verso una legge elettorale, che non preveda la preferenza, in quanto, con questo meccanismo di voto, essi hanno la possibilità, attraverso metodologie di tipo cooptativo, di scegliere integralmente quel ceto parlamentare che rappresenta, evidentemente, il primo necessario collante fra gli elettori ed il mondo delle istituzioni rappresentative.
Ne va che la qualità dei processi democratici si svilisca e non poco, visto che la politica - in quanto suprema forma di manifestazione e svolgimento della partecipazione popolare ai processi decisionali - non può essere equiparata alla mera riproduzione di un baronato accademico o sociale.
La cultura del maggioritario, prima, e poi la nascita di meccanismi elettorali di tipo proporzionale, privi però della preferenza, hanno rafforzato questa tendenza, per cui, in questo momento in Italia, anche per la concomitante assenza dei partiti, tipici della I Repubblica, i criteri di formazione della classe dirigente sono sempre più oscuri e meno rispondenti ad un protocollo, sinceramente, democratico.
I gruppi parlamentari di tutte le formazioni odierne, dalla Destra alla Sinistra, si arricchiscono così di individui, la cui presenza è, talora, in forte stridore con il delicato mandato istituzionale, che vanno a svolgere: la qualità complessiva del ceto politico, pertanto, si abbassa sempre più, in quanto l’assenza di scuole di partito - quali quelle che sono esistite nel nostro Paese nel secolo scorso - determina a maggior ragione l’impossibilità che i nuovi eletti possano venir fuori da un percorso, da un punto di vista culturale e politologico, autenticamente formativo.
Per siffatta strada, la democrazia, già precaria ed incerta, rischia di divenire ulteriormente attività riservata a pochi “eletti”, i quali vengono scelti sulla base di parametri, alquanto, discutibili: dall’avvenenza femminile - sempre utile, invero, come strumento comunicativo - alla simonia, dal momento che risulterebbe che molti dei parlamentari di nuova nomina, in alcuni partiti in particolar modo, hanno acquisito il diritto all’elezione, elargendo un corposo contributo in danaro a chi aveva la responsabilità, in nome e per conto del Capo, di comporre le liste.
È, forse, giunto il momento che un simile meccanismo si interrompa e si torni all’effettiva partecipazione popolare al processo legislativo?
L’unico strumento, che garantirebbe un ritorno alle origini ateniesi del concetto stesso di “democrazia”, è rappresentato dal referendum, ma il legislatore, nel nostro Paese, si è sempre preoccupato di limitarne la portata e l’uso, per cui i Padri Costituenti, nel biennio 1946-48, decisero di non introdurre nella Carta il modello propositivo, optando solo in favore di quello confermativo/abrogativo; nelle settimane scorse, in sede di varo della riforma della Costituzione, la maggioranza parlamentare ha deciso di indebolire, finanche, il mezzo del referendum abrogativo, prevedendo una soglia più alta di firme, perché ne possa essere autorizzata l’indizione, una volta verificata l’ammissibilità del quesito referendario da parte della Corte Costituzionale.
È, peraltro, assai anomalo un atteggiamento frequente di molti autorevoli rappresentanti politici, che sono pronti a gridare allo scandalo, strepitando contro l'invadenza delle più autentiche élites, quando una testata giornalistica di spessore o un’importante associazione di categoria o una nota agenzia di rating internazionale si permettono il lusso di criticarne l’operato: solo in quel momento, il ceto degli eletti manifesta un sussulto di dignità ancora residuale, aspirando a far valere i propri presunti gradi di ceto eletto e non nominato per cooptazione o per prestigio accademico o per prerogative sociali, discendenti da un chiaro potere economico.
Sembra, così, ancora più meschina ed autoreferenziale una classe politica, che agisce in modo siffatto: quando, finalmente, essa procederà ad una riforma radicale di se stessa, ritrovando la legittimazione smarrita attraverso un tentativo serio - né ingenuo, né malizioso - di radicamento nel corpo vitale della società?
Rosario Pesce



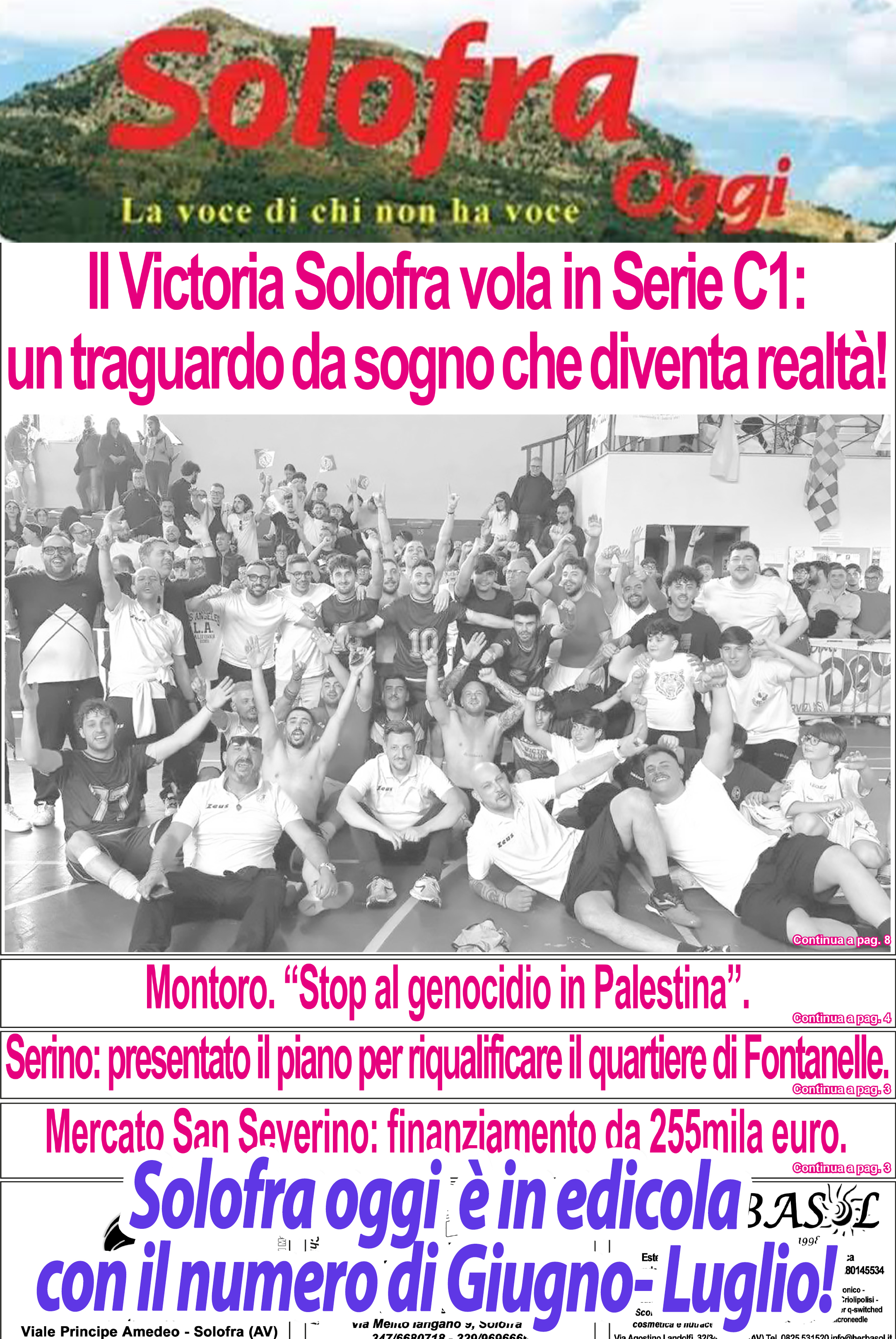
.jpg)