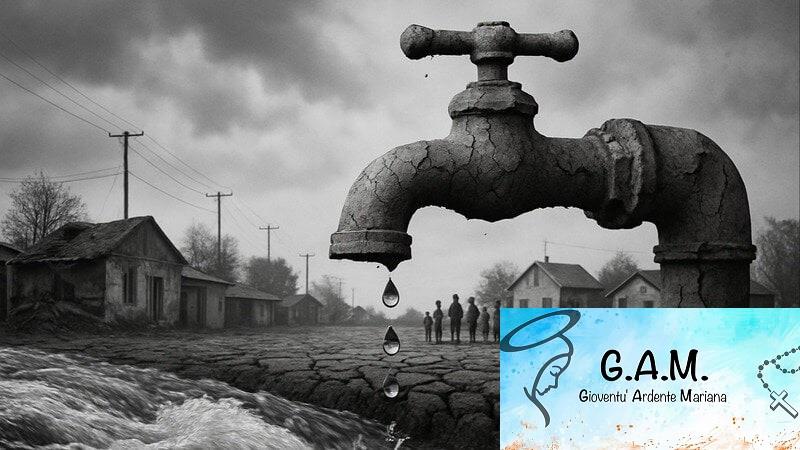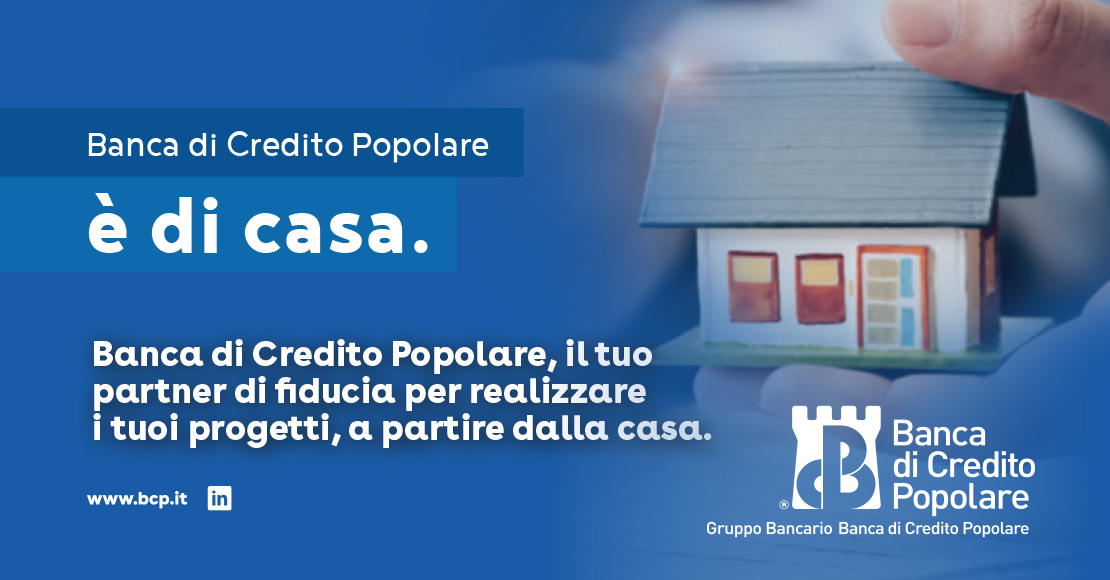L’Europa e gli Stati-nazione: una questione di sovranità
Nei giorni scorsi, il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dopo la pubblicazione degli esiti dell’indagine Istat sulla condizione del sistema economico italiano, ha reso una dichiarazione, che ha fatto scalpore, pur non essendo del tutta imprevista: egli, infatti, ha chiesto agli Stati, che rientrano nella zona euro, di cedere ulteriori quote di sovranità all’Unione, in modo tale da accelerare il processo di unificazione del nostro continente.
È evidente che le parole del massimo esponente del mondo bancario europeo siano intrise di problematiche di non scarso peso: l’Italia, come gli altri Stati, ha già ceduto la sovranità monetaria, nel momento in cui essa ha accettato di abbandonare la propria divisa e di acquisirne una – l’euro, appunto – su cui nessuno Stato vanta alcun poter decisionale, visto che sono i vertici di Bruxelles e Francoforte a decidere quanto denaro debba essere messo in circolazione ed, in particolare, quale tasso d’interesse debba essere praticato dalle banche commerciali, quando esse realizzano, quotidianamente, le loro transazioni finanziarie.
Non a caso, se ci fossimo trovati in tempo pre-euro, la crisi attuale, dovuta alla deflazione e alla restrizione dei consumi, si sarebbe risolta battendo nuova moneta ed accettando, così, il rischio di inflazione, pur di riavviare un’economia, invece, oggi spenta e quasi prossima alla stagnazione irreversibile.
Quindi, tornando all’oggetto della nostra riflessione, a cosa faceva riferimento Draghi?
Egli, primariamente, si riferiva alla normativa in materia di lavoro che, ancora tuttora, rientra nelle competenze degli Stati nazionali: in questi mesi, ad esempio,il Parlamento italiano sta discutendo il cosiddetto Jobs Act, cioè il provvedimento “omnia”, che dovrebbe riformare il regime contrattuale dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo scopo di favorire il rilancio della nostra economia, anche attraverso la rimodulazione dei contratti di lavoro subordinato.
Su questo tema così delicato si sta, pertanto, configurando una competenza concorrente che, forse, anche a ragione, Draghi vuole rimettere, per intero, alla sfera di attribuzione degli organismi comunitari; non è certo un caso se l’intervento del Presidente della B.C.E. avviene qualche giorno dopo una clamorosa iniziativa della C.G.I.L., cioè del principale sindacato italiano, che ha denunciato alla Commissione di Bruxelles il Governo Renzi, per eccessivo uso dei contratti a tempo determinato, mentre, ormai da qualche anno, l’Unione invita gli Stati ad incentivare i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allo scopo di dare una prospettiva di vita più dignitosa a quanti sono alla ricerca di un impiego più stabile e sicuro.
Quindi, si evince che, già nel sistema attuale, attraverso le direttive, l’Unione tenta di far ascoltare la sua voce ai vari Governi, soprattutto quando il loro operato va in un senso manifestamente diverso da quello indicato dai vertici comunitari, pronti ad intervenire e a sanzionare l’eventuale mancato rispetto della normativa sovranazionale che, in quanto fonte di diritto, dotata di un’intrinseca supremazia rispetto a quella dei singoli Stati, diventa, per i giudici nazionali, elemento essenziale per l’orientamento in sede giurisdizionale; accade, di frequente, che molti giudici del lavoro, ad esempio, facciano valere il diritto europeo contro quello nazionale, usandolo come bussola per districarsi nel labirintico affollamento di leggi di varia natura ed epoca storica.
Pertanto, contrariamente a molti, non ci scandalizziamo per le dichiarazioni di Draghi, sapendo bene che quello dell’unificazione europea è un processo ormai irreversibile, che va assecondato e corretto, laddove necessario, ma certamente non ostacolato con spirito pregiudiziale.
In Italia, come in molti altri Paesi, è vivo - da tempo - un dibattito fortissimo, che vede protagoniste la Destra qualunquistica e la Sinistra post-marxista, insolitamente alleate contro l’Unione e schierate in difesa di un nazionalismo che ricorda, in modo sbiadito, quello della storia del XIX e del XX secolo.
È, probabilmente, giusta l’obiezione di taluni che accusano gli organismi di Bruxelles e Francoforte di essere, sostanzialmente, autoreferenziali ed, in quanto non-elettivi, di essere anti-democratici per loro natura, non essendo espressione della volontà popolare.
Una simile posizione, per quanto giusta se riferita, in modo particolare, alla Banca Centrale Europea, presenta qualche lato debole: quale banca o banchiere è espressione di un potere, autenticamente, democratico?
Anche, quando la sovranità era ancora appannaggio degli Stati nazionali e delle loro Banche Centrali, il Parlamento per nulla poteva entrare nel merito delle decisioni di siffatti organismi, per cui molto spesso era la politica (quella nazionale, appunto) a correre dietro al potere finanziario-bancario e non viceversa, per cui la condizione attuale è, semplicemente, la riproduzione, su una scala più vasta, di un dato di fatto strutturale nelle economie tipiche del capitalismo finanziario avanzato, a prescindere dall’ampiezza del territorio dello Stato di riferimento e della sfera giuridica conseguente.
Altra contro-deduzione alle obiezioni degli euroscettici: se la Banca Centrale Europea non avesse fatto, nel corso dell’ultimo decennio, il suo mestiere, così come egregiamente è stato condotto, molte economie sarebbero già crollate; il pensiero è diretto alla nostra condizione, ma anche altre nazioni si sarebbero trovate in difficoltà ed avrebbero fatto la medesima fine della Grecia.
Infatti, molto spesso ci si dimentica che i titoli di Stato vengono acquistati, su impulso del massimo organismo finanziario continentale, in modo continuo e costante, così da assicurare all’Italia, come ad altri Paesi, che l’incubo del default si allontani sempre più.
Infine, al di là di ogni riferimento di natura meramente economicistica, c’è una riflessione più importante da condurre: la storia continentale ha visto, sin dal Medioevo, l’alternarsi di una prospettiva di chiusura particolaristica (il regionalismo ed il municipalismo della prima età moderna), contrapposta ad un orizzonte più ampio, rappresentato dall’universalismo dell’Impero e della Chiesa che, per secoli, hanno combattuto contro gli Stati nazionali, venendone sconfitti fra la fine dell’Ottocento ed il primo Conflitto Mondiale, quando il Papa perse il potere temporale (1870) e tutti gli Imperi Centrali scomparvero dalla carta geografica, per effetto dei Trattati di Pace di Parigi conseguenti alla conclusione della Grande Guerra.
Orbene, il trionfo dell’idea di nazione è stata foriera, purtroppo, di degenerazioni che sono alla base dei più grandi crimini commessi nel corso del XX secolo: il nazionalismo esasperato dei Tedeschi ha prodotto il dramma del nazismo e della seconda Guerra Mondiale, che rappresentano il dato storico più aberrante dell’uomo contemporaneo.
Pertanto, pur comprendendo le ragioni di chi chiede un ritorno allo Stato nazionale, per riportare al centro dell’universo il cittadino-elettore, spodestato sempre più dalla figura del mero produttore di merci e da quella, ben più inquietante, del debitore/creditore, non si può – per ovvie ragioni – non continuare ad essere europeisti, sapendo che la civiltà giuridica dell’Unione mette insieme tradizioni e culture, che hanno respiro diverso da quelle, strettamente, nazionali.
Per tal via, conoscendo vieppiù la condizione di discredito dei politici italiani odierni, ormai ridotti ad essere solo lo spettro di una defunta classe dirigente, che pure c’è stata nel nostro Paese, fino agli anni Ottanta, non si può non aupicare che l’Europa, effettivamente, proceda al commissariamento dei governi nazionali, che usano, in modo meramente strumentale, le argomentazioni pauperistiche contro i poteri “pluto-sionisti” e tecnocratici di Bruxelles e Francoforte, scimmiottando il regime nazista e quello fascista, che adottavano espressioni simili contro le democrazie occidentali, alla fine degli anni Trenta.
Chi scrive, per ragioni anche letterarie, ha sempre creduto che l’idea imperiale incarni il sogno più vero di civiltà da parte del mondo occidentale, dal Barbarossa a Federico II, da Carlo V d’Asburgo a Carlo III di Borbone: l’Europa, scevra dalle problematiche delle Corone dell’età moderna, può ricreare oggi uno spazio di nuova concezione, entro cui consentire a vecchi e nuovi Europei, appena immigrati, di vivere e crescere in un clima di pace.
Non si interrompa, quindi, questa bella visione, evocando un’idea di democrazia nazionale molto “sui generis” e, soprattutto, inadeguata a risolvere i problemi odierni, che non sono più immaginabili entro uno schema meramente nazionale, visto che dell’idea di Stato-nazione, di ottocentesca memoria, è venuto meno il presupposto fondamentale: l’intangibilità del territorio, sempre più – giustamente – aperto alla libera circolazione di merci ed uomini.
Rosario Pesce



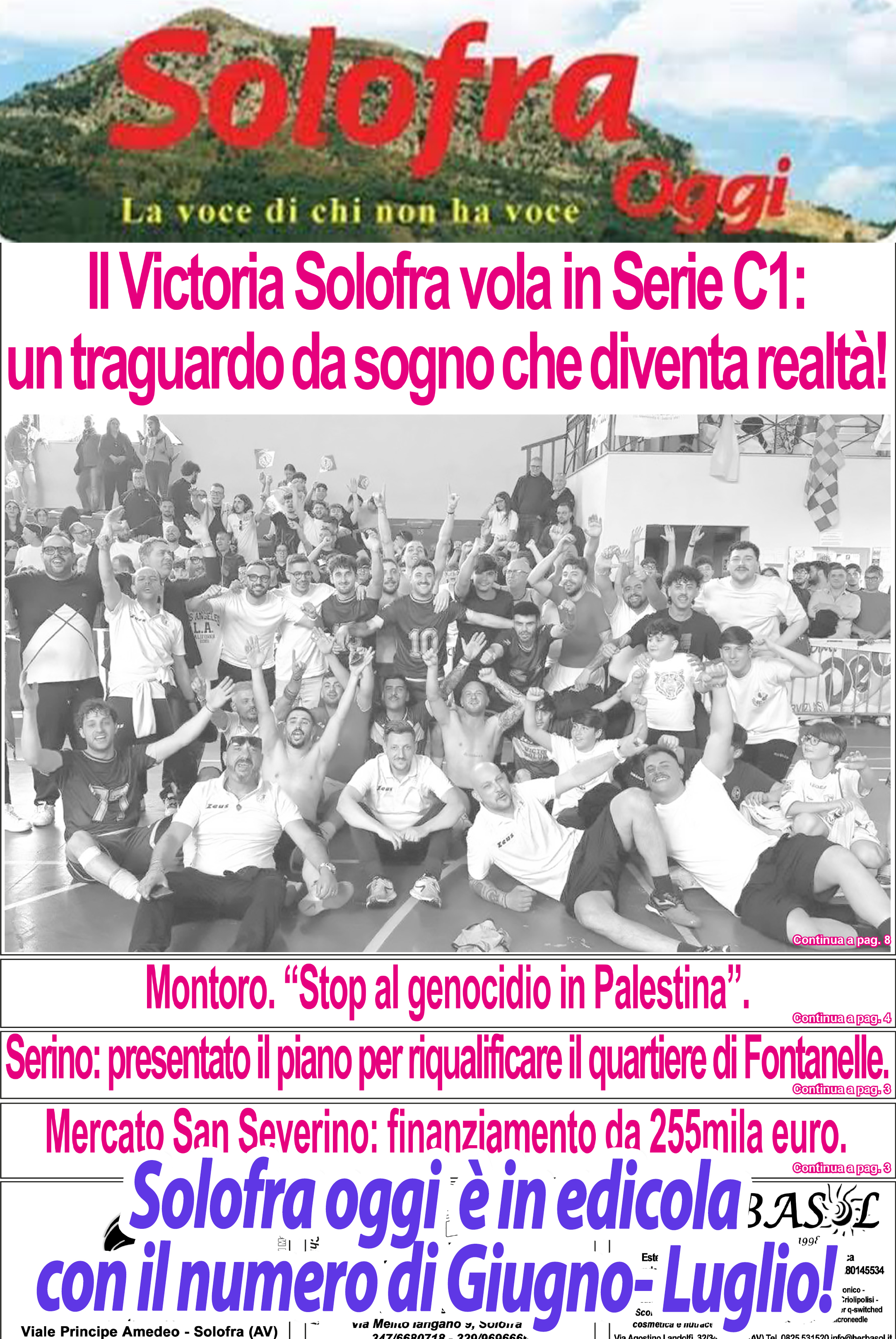
.jpg)