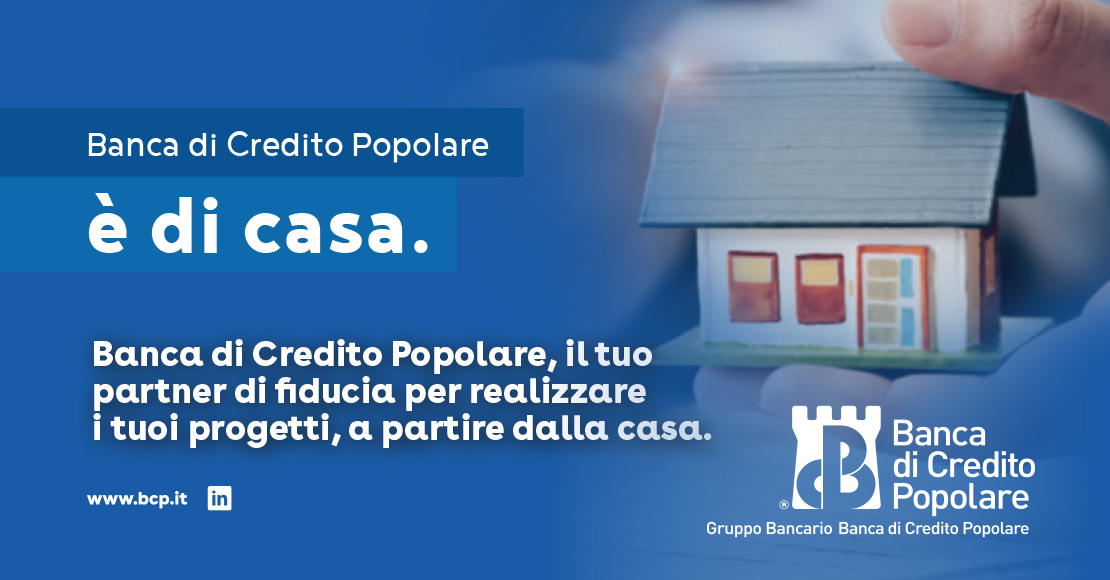Azienda agricola Vincenzo Di Domenico: incontro di tre generazioni nel segno della natura
Alcuni anni fa, ho conosciuto il professore Vincenzo Di Domenico nell’ISISS “G. Ronca” di Solofra, come persona socievole, poliedrica, ma, soprattutto, amante e custode della natura, oltre ad essere un ottimo commercialista.
Difatti, nel predetto Istituto ha integrato, sempre, la teoria con la pratica, anche grazie ai suoi collaboratori.
Inoltre, vorrei sottolineare che, durante le ore libere dalle attività didattiche, solevo dialogare con Vincenzo, soffermandoci sull’economia agricola, commerciale ed industriale della nostra Irpinia.
Il più delle volte, ci confrontavamo sul settore primario dell’Irpinia. Era curioso di sapere della realtà socio - economica di Solofra e del suo sviluppo conciario. In sintesi, gli raccontai che la concia è venuta fuori grazie al settore primario, alle greggi, al tannino per la concia che si ricavava dalla corteccia del castagno e alla bravura artigianale dei conciatori, aggiungendo che nella nostra ricchissima valle scorrevano latte e miele, ma, poi, negli anni Settanta la terra fertilissima ha fatto spazio all’industria conciaria.
Interrompendomi, mi disse che ero nostalgico del mondo rurale, soprattutto quando il grano ondeggiava nella fascia pedemontana dei “Picentini”.
E aggiunse che la nostra Irpinia dalla Baronia all’alta Irpinia, dal “Formicoso” alla valle dell’Ufita, si conferma un territorio, prevalentemente, verde, in quanto primeggiano la viticoltura, la cerealicoltura, ma, soprattutto, un granaio dove brilla l’oro biondo, molto apprezzato sulle tavole italiane.
A mia volta, gli dissi che lui ne parlava con dimestichezza ed una comunicativa eccellenti tanto da farmi venire reminiscenze, allorquando i contadini donne e uomini mietevano il grano utilizzando le mani e la falce.
Quindi, il sudore scendeva per il fondoschiena e ci si asciugava con stracci e con una buona sorsata di vino e tutti vicino allo stesso fiasco, si pranzava insieme, dove si esprimevano nei gesti accoglienza, fratellanza e solidarietà.
Erano tutti contenti a mietitura avvenuta, senza tralasciare nessuna spiga sul terreno, compito delegato ai fanciulli nel raccoglierle, e, poi, si trasportavano i covoni e si ammassavano sulle aie, nell’attendere la macchina trainata dai cavalli, al fine di eseguire la trebbiatura e, quindi, il recupero del grano e della paglia. Quest’ultima veniva raccolta in mete con una tecnica spiovente, con una pertica al centro della stessa paglia, rendendola impermeabile, al fine di poterla utilizzare, durante l’anno, per lettiera agli animali. Inoltre, si ringraziava il Signore per la grazia del raccolto, con usi e tradizioni locali, rievocando nell’evento l’aspetto antropologico e sociale, al fine di diffondere alle nuove generazioni un testimone trasmessoci dai nostri padri, facendo rivivere la cultura della terra ovvero della fatica del contadino che vive dei frutti del suo lavoro, legato alle condizioni climatiche, che potrebbero devastare la mietitura.
Ecco, l’esplosione di gioia si manifestava in canti, balli, rituali e tanto altro avveniva nelle valli dell’Irno e del sabato, negli anni settanta.
Con un sorriso marpione, Vincenzo rispose che, se nella Bassa Irpinia non si vivono, più, questi momenti, nell’Alta Irpinia si continua con feste e tradizioni che coinvolgono turisti, come nella notte del grano, in quel di Aquilonia o in quel di Casalbore, anche se la meccanizzazione ha preso il posto della falce e della trebbiatrice.
Durante il dialogo, vengo a conoscenza dell’introspezione dell’animo di Vincenzo, che continua la tradizione dell’azienda agricola del padre Alfonso, di circa 30 ettari di terreno, coltivati a grano, in località “Contrada Serra Dei Mortali “a Teora?.
In effetti, suo padre gli ha trasmesso l’amore per la natura, fonte della nostra vita e, quindi, da rispettare e custodire, anche se il macchinismo ha preso il posto dell’aratro e della falce.
A sua volta, Vincenzo sta passando il testimone ai suoi figli, anche loro professionisti, che sono entusiasti di aiutarlo nella semina e nel raccolto.
Come si evince dalle foto, non si formano, più, i covoni, in quanto il macchinario svolge, contestualmente, le operazioni di falciatura e trebbiatura, dividendo il grano dalla paglia che, nello stesso istante, viene arrotolato in grandi balle lasciate sul terreno.
A testimonianza della tipica arte irpina del grano, giova ricordare che le tradizioni nei Comuni di Flumeri, Villanova dei Battista, Mirabella Eclano e Fontanarosa sono interrelate, nel nome dei rituali legati al grano e ai propri santi Patroni.
Infatti, a Fontanarosa il ciclo del grano viene attualizzato con carri ed obelischi, alti fino a 35 metri, realizzati con la pazienza e sapienza artigianale locale con chicchi e spighe di grano intrecciate, il tutto sotto le mani delle donne, coadiuvate dagli uomini, per, poi, portarli in processione.
A questa partecipa l’intera comunità, in un clima di gioia unanime. L’obelisco viene trainato da carri e dai buoi e dagli uomini, che con delle funi tengono l’equilibrio dell’obelisco, al fine di non farlo cadere, e portarlo per le strade principali del paese.
In sintesi, il grano è l’oro dell’Irpinia insieme al fiano di Avellino e al greco di Tufo.
DIR




.jpg)